|
|
| Recensione di 'L'italiano nel cinema' |
|---|
19/11/2017 | 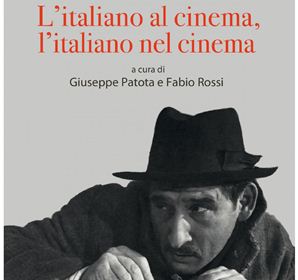 Nella lingua del cinema cominciano ad essere attestati, e soprattutto ad intensificarsi, tratti comunemente considerati vicini al parlato, come, per esempio, subordinate con indicativi al posto del congiuntivo e periodi ipotetici semplificati, realizzati con l’imperfetto indicativo e frasi scisse; usi in cui il” che” funge da generico indicatore di subordinazione, battute in cui la sintassi riflette i cambiamenti di progetto tipici dell’orale o interrogative realizzate con cosa e la negazione mica. A questo si aggiunge la maggiore disinvoltura degli attori sullo schermo, che improvvisano prese di turno pause, e così via. Se la rappresentazione e la parodia più o meno velata giustificano la presenza di forestierismi nel parlato filmico, ancora più variegata è la posizione del cinema riguardo alla dialettofobia di regime, probabilmente perché la stessa posizione del regime era ambigua: per la maggioranza della popolazione il dialetto, infatti, era una lingua parlata, e soprattutto un elemento fortemente identitario e tradizionale, coerente anche con alcuni aspetti dell’ideologia fascista. Per questo la campagna contro il dialetto non ebbe l’ampia risonanza nell’opinione pubblica che ebbe la guerra ai forestierismi, e il regime, pur combattendolo nelle aule scolastiche e diramando disposizioni alla stampa contro l’uso del dialetto a partire dal 1931, tollerò la sua pur annacquata presenza in diversi ambiti della vita pubblica, compreso lo schermo. Il parlato filmico degli anni Trenta, contrariamente alle aspettative, è dunque tutt’altro che monolitico, ma documenta aperture a influssi regionali e ad altre lingue. Secondo Raffaelli (1992: 81) si possono distinguere tre periodi: gli anni della Cines (1929-1934), il periodo in cui si registra la massima apertura alle varietà regionali; gli anni di Freddi (1935-1939), dominati dal culto dell’italiano asettico, senza accento; gli anni della guerra, in cui il dialetto viene impiegato con funzione macchiettistica, ma anche già con un intento realistico. Nella lingua del cinema cominciano ad essere attestati, e soprattutto ad intensificarsi, tratti comunemente considerati vicini al parlato, come, per esempio, subordinate con indicativi al posto del congiuntivo e periodi ipotetici semplificati, realizzati con l’imperfetto indicativo e frasi scisse; usi in cui il” che” funge da generico indicatore di subordinazione, battute in cui la sintassi riflette i cambiamenti di progetto tipici dell’orale o interrogative realizzate con cosa e la negazione mica. A questo si aggiunge la maggiore disinvoltura degli attori sullo schermo, che improvvisano prese di turno pause, e così via. Se la rappresentazione e la parodia più o meno velata giustificano la presenza di forestierismi nel parlato filmico, ancora più variegata è la posizione del cinema riguardo alla dialettofobia di regime, probabilmente perché la stessa posizione del regime era ambigua: per la maggioranza della popolazione il dialetto, infatti, era una lingua parlata, e soprattutto un elemento fortemente identitario e tradizionale, coerente anche con alcuni aspetti dell’ideologia fascista. Per questo la campagna contro il dialetto non ebbe l’ampia risonanza nell’opinione pubblica che ebbe la guerra ai forestierismi, e il regime, pur combattendolo nelle aule scolastiche e diramando disposizioni alla stampa contro l’uso del dialetto a partire dal 1931, tollerò la sua pur annacquata presenza in diversi ambiti della vita pubblica, compreso lo schermo. Il parlato filmico degli anni Trenta, contrariamente alle aspettative, è dunque tutt’altro che monolitico, ma documenta aperture a influssi regionali e ad altre lingue. Secondo Raffaelli (1992: 81) si possono distinguere tre periodi: gli anni della Cines (1929-1934), il periodo in cui si registra la massima apertura alle varietà regionali; gli anni di Freddi (1935-1939), dominati dal culto dell’italiano asettico, senza accento; gli anni della guerra, in cui il dialetto viene impiegato con funzione macchiettistica, ma anche già con un intento realistico.
Più che di dialetto in molti casi bisognerebbe parlare di “italiani regionali”, cioè dell’italiano che varia nelle diverse aree linguistiche italiane, risentendo soprattutto nell’orale delle realtà linguistiche locali.
A favorire la presenza di tratti regionali, soprattutto per quanto riguarda la dizione, ma in alcuni casi di autentici frammenti dialettali, è la frequente contiguità con la scena teatrale in cui i grandi attori (e autori) continuavano a raccogliere successi. Quando approdano allo schermo portano con sé echi vistosi di un parlato regionale disinvolto e popolare: è così per il toscano de L’acqua cheta (1933, Gero Zambuto), dalla commedia di Augusto Novelli; per il milanese di Felicita Colombo (1937, Mario Mattoli) e Nonna Felicita (1938, Mario Mattoli), con Dina Galli e Armando Falconi, dai testi di Giuseppe Adami; per il siciliano di Aria del continente (1935, Gennaro Righelli), con Angelo Musco, da Martoglio. Anche nell’era Freddi, il dialetto rimane, soprattutto in bocca a personaggi di contorno o comici, come, elemento irrinunciabile per dare verità ad ambientazioni come l’Ivrea di Tristi amori, o la Torino di Addio giovinezza! in cui ricorrono il saluto piemontese cerea, il madamin rivolto alle signore, la tota Dorina, il cadreghin, cioè la poltrona, tutti dialettismi noti e stereotipati anche per il pubblico. L’uso più interessante degli inserti dialettali o dei tratti regionali italiani è tuttavia quello che si registra nel cosiddetto filone “risorgimentale”, cioè nei film che hanno per soggetto episodi della storia risorgimentale e, in generale, od in quelli di guerra. Nel bellissimo 1860 di Alessandro Blasetti (1934), capostipite del genere, il valore simbolico del processo di unificazione si esprime anche attraverso le lingue che vengono utilizzate nel film, le parlate emiliane, fiorentine, venete e siciliane dei volontari rappresentano la loro provenienza da tutta Italia, una nazione divisa, anche linguisticamente, la cui unità include, come una sintesi superiore, le parti di cui è composta. I dialetti, in sostanza, tendono e concorrono naturalmente all’unità della nazione; le uniche lingue veramente estranee, che non è possibile integrare, sono il francese dei soldati che salvano il naufrago siciliano a Civitavecchia e il tedesco dei soldati che interrogano la moglie del naufrago. La tensione verso l’unità trova una precisa, e altamente simbolica, rappresentazione linguistica, tracciando confini netti che includono o escludono. Ma all’interno della comunità linguistica nazionale, nel film di Blasetti sembra essere anche indicato il ruolo delle realtà regionali dialettali, cioè l’espressione degli affetti familiari: il suggestivo addio alla madre del volontario veneto sugli scogli di Quarto è un colloquio in veneto. Come a più riprese è stato detto e scritto da grandi scrittori a proposito del rapporto fra dialetto e italiano, il dialetto è il luogo dell’intimità familiare.
Biagio Gugliotta
|
|

| | |
archivio
| ALTRE NEWS
|
 7/12/2025 - Muro Lucano ha un nuovo punto di vista sulla sua bellezza 7/12/2025 - Muro Lucano ha un nuovo punto di vista sulla sua bellezza
A Muro Lucano è stata inaugurata la panchina gigante del progetto Big Bench Project in località Piani del Casino, un’idea fortemente voluta e portata avanti dalla Pro Loco Murese in sinergia con l’Associazione Un Muro D’Amare per valorizzare uno dei panorami più straordinari...-->continua |
|
|
|
|
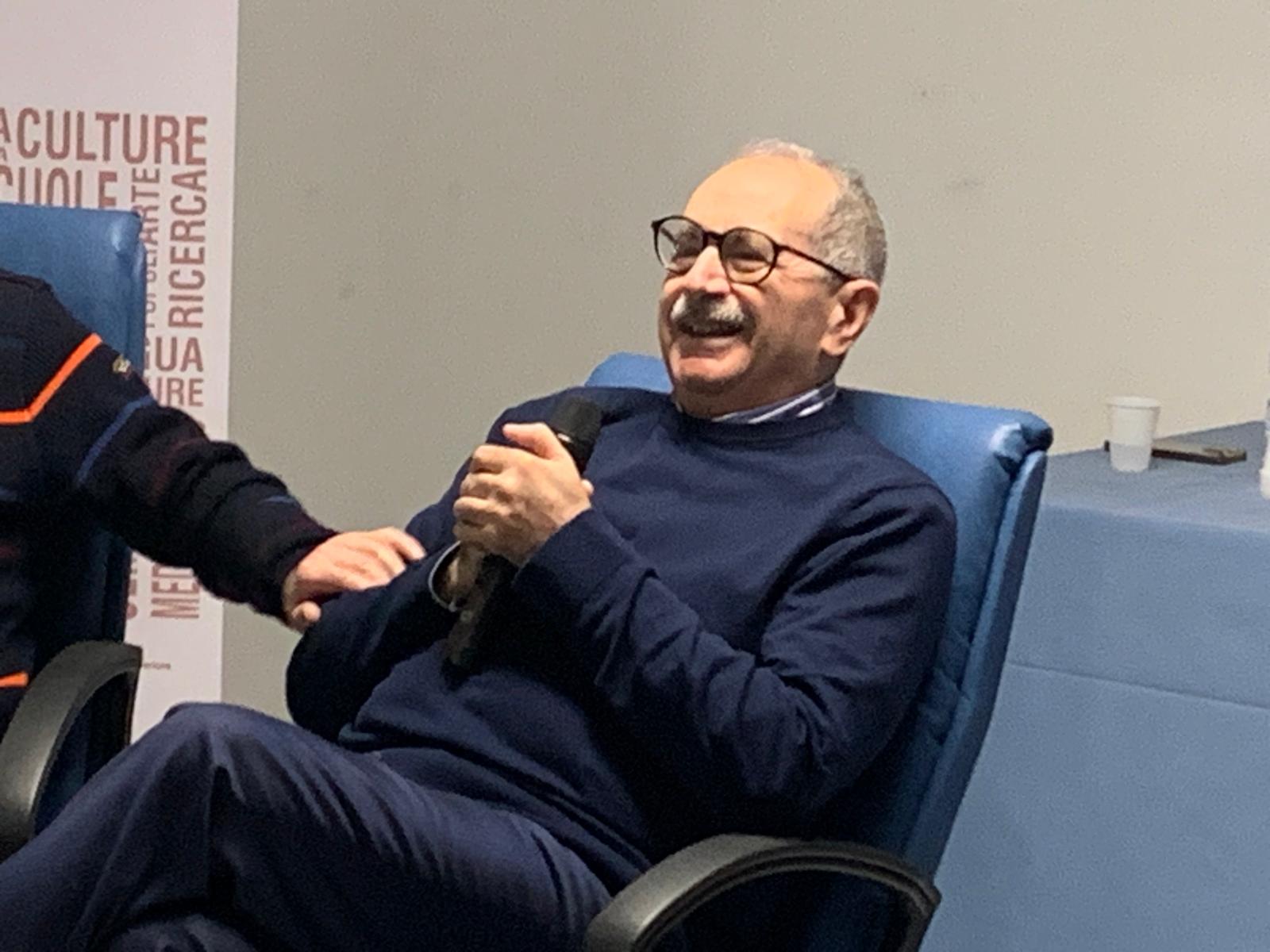 7/12/2025 - Vito Teti a San Paolo Albanese: radici, migrazioni e restanza per un futuro possibile 7/12/2025 - Vito Teti a San Paolo Albanese: radici, migrazioni e restanza per un futuro possibile
Vito Teti, tra i più autorevoli antropologi italiani, ha incontrato giovani e cittadini a San Paolo Albanese, il più piccolo comune lucano di origine arbëreshë. Con il suo tono pacato e profondo, ha parlato di migrazioni, radici, partenze e ritorni, temi che a...-->continua |
|
|
|
|
 7/12/2025 - Il lucano Aniello Ertico insignito dal Ministero della Cultura egiziano al XVIII Simposio d’Arte di Luxor 7/12/2025 - Il lucano Aniello Ertico insignito dal Ministero della Cultura egiziano al XVIII Simposio d’Arte di Luxor
Il lucano Aniello Ertico, presidente e fondatore di Porta Coeli Foundation, è stato ospite d’onore del XVIII Simposio d’Arte di Luxor, prestigioso appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura egiziano, realizzato dal 18 al 27 novembre 2025. Durant...-->continua |
|
|
|
|
 6/12/2025 - Il Sicomoro, Caritas e comune di Matera, i Custodi del Bello tra solidarietà e cura dei beni comuni 6/12/2025 - Il Sicomoro, Caritas e comune di Matera, i Custodi del Bello tra solidarietà e cura dei beni comuni
Nelle scorse settimane, i Custodi del Bello di Matera hanno portato a termine due importanti iniziative dedicate al lavoro, alla solidarietà e alla valorizzazione dei beni comuni.
La prima attività ha riguardato la raccolta delle olive all’interno del Parc...-->continua |
|
|
|
|
E NEWS
|
WEB TV
|

![]()
![]()

![]()
![]()