E qualcuno si permette
ancora di sognare.....
(dal blog di Beppe
Grillo)
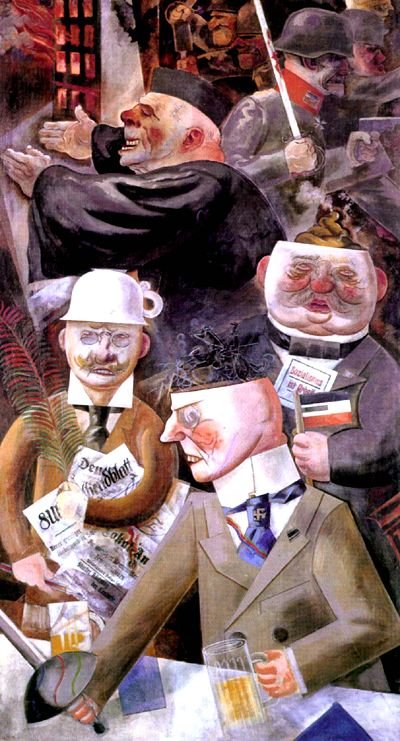 Più
di 100 giornali o periodici cattolici sono finanziati dallo
Stato. Ma non erano sufficienti l'otto per mille e l'esenzione degli immobili
religiosi dall'ICI? Le nostre tasse contribuiscono a "La Voce dei Berici
della Diocesi di Vicenza" e a "La Valsusa della Stampa Diocesana
Segusina".
Più
di 100 giornali o periodici cattolici sono finanziati dallo
Stato. Ma non erano sufficienti l'otto per mille e l'esenzione degli immobili
religiosi dall'ICI? Le nostre tasse contribuiscono a "La Voce dei Berici
della Diocesi di Vicenza" e a "La Valsusa della Stampa Diocesana
Segusina".
Imperdibili per i fedeli più devoti.
"Le testate percettrici di contributi diretti, relativi all’anno 2003,
risultavano dunque 386, divise in otto categorie...
QUARTA CATEGORIA: in pratica, monopolio di testate facenti capo, direttamente o
indirettamente, alla Chiesa cattolica (diocesi, arcidiocesi,
ordini religiosi, conventi, associazioni e opere pie, confraternite, ecc.). Fra
i 106 «periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali
ovvero da società il cui capitale sociale sia detenuto da cooperative,
fondazioni o enti morali» si contavano sulla punta delle dita di una sola mano
quelli editi da organizzazioni non cattoliche come l’Istituto Buddista e non
religiose come l’ANMIL (Associazione dei Mutilati e Invalidi del Lavoro) e la
Federazione Orticoltori.
A primeggiare era la Società San Paolo. Fondata nel 1914 da don Giacomo
Alberione, opera in trenta nazioni «e in molteplici campi di attività: editoria
libraria, giornalistica, cinematografica, musicale, televisiva, radiofonica,
audiovisiva, multimediale, telematica; centri di studio, ricerca, formazione,
animazione». I Paolini sono impegnati programmaticamente e sistematicamente
«nella diffusione del messaggio cristiano utilizzando i mezzi che la tecnologia
mette a disposizione dell’uomo di oggi per comunicare». E la Periodici San
Paolo, in particolare, riusciva a utilizzare puntualmente anche i contributi
messi a disposizione dallo Stato italiano, assommando con sei testate una cifra
superiore al miliardo delle vecchie lire: Famiglia Cristiana (210
mila euro), Il Giornalino (210 mila),
Jesus (49 mila), Vita Pastorale (34
mila), Famiglia Oggi (5 mila) e Letture
(5 mila).
A parte la San Paolo, la gran parte delle testate di questa categoria si
accontentavano di contribuzioni sotto i 50 mila euro: la più bassa in assoluto,
meno di duemila euro, quella assicurata alla Impresa Tecnoeditoriale Lombarda
per la Rivista Diocesana Milanese. Solo quindici riviste riuscivano ad
aggiudicarsi un aiuto pubblico compreso fra i 50 mila e i 100 mila euro:
L’amico del Popolo (102 mila), Città Nuova della
Pia Associazione Maschile opera di Maria (94 mila),
Toscana Oggi (89 mila), La Vita del Popolo dell’Opera
San Pio X (82 mila), Corriere di Saluzzo (80
mila), Verona Fedele (74 mila), Il Popolo
dell’Opera Odorico da Pordenone (65 mila), La Vita
Cattolica (64 mila), L’Azione della Diakonia
Ecclesiale (63 mila), La Difesa del Popolo (61
mila), La Voce dei Berici della Diocesi di Vicenza (57
mila), Adista «fatti, notizie, avvenimenti su mondo cattolico
e realtà religiose» (56 mila), La Voce del Popolo
«settimanale di informazione della cultura cattolica di Brescia. Documenti e
informazioni sulla Diocesi e sulla Curia Vescovile» (56 mila),
Il Nuovo Rinascimento dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (52
mila) e La Valsusa della Stampa Diocesana Segusina (51 mila).
Nel 2004 queste testate passeranno da 106 a 115, per una
contribuzione complessiva di 3 milioni 674 mila."Beppe
Lopez, La Casta dei giornali, ed. Nuovi Equilibri
__________________________
 Di
fronte al numero sterminato di giornali assistiti la prima
reazione è di farne subito uno per prendere finalmente uno stipendio. Se
Fare Vela e Sportsman -Cavalli e Corse hanno ricevuto un
finanziamento lo possono pretendere tutti, dai blog ai giornali di quartiere
Di
fronte al numero sterminato di giornali assistiti la prima
reazione è di farne subito uno per prendere finalmente uno stipendio. Se
Fare Vela e Sportsman -Cavalli e Corse hanno ricevuto un
finanziamento lo possono pretendere tutti, dai blog ai giornali di quartiere
"Le testate percettrici di contributi diretti, relativi all’anno 2003,
risultavano dunque 386, divise in otto categorie...
TERZA CATEGORIA: cooperative vere, quasi vere, false. E cioè sessantotto
«quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti o da società la cui
maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative nonché quotidiani
italiani editi e diffusi all’estero e giornali in lingua di confine».
Notevoli, in questo elenco, i trucchi, i travestimenti e le
diavolerie messe in atto per acquisire contributi pubblici anche di notevole
consistenza. La lista era capeggiata da una strana terna: l’Avvenire,
diffuso e autorevole organo della potente Conferenza Episcopale Italiana, con
5.999.900,04 euro; Italia Oggi, battagliero
«quotidiano economico, giuridico e politico, per i professionisti dell’economia
e del diritto» della ClassEditori (gruppo con 270 dipendenti, quotato in Borsa
ma formalmente posseduto al 50,01 per cento dalla coop Coitalia), con
5.061.277,60; Il Manifesto, storico «quotidiano comunista»,
edito dalla cooperativa editoriale più autentica e più autorevole esistente nel
nostro Paese, con 4.441.529,33.
Dietro il Primorski Dnevnik (2.969.627,17 euro), una
decina di altre testate dalla svariata tipologia e qualità, accreditate di
contributi fra i 2 milioni e i 2 milioni e mezzo di euro:
America Oggi, «quotidiano italiano pubblicato negli Stati Uniti»;
Conquiste del Lavoro, «quotidiano della CISL fondato nel 1948 da Giulio
Pastore» (2.582.284,89); l’Avanti! «quotidiano
socialista»; Il Cittadino, «quotidiano lodigiano e del SudMilano»;
Corriere di Forlì, Corriere di Perugia, Corriere di Firenze,
Corriere Canadese, Corriere del Giorno di Puglia e Basilicata,
Il Corriere Mercantile, Editoriale Oggi (Ciociaria Oggi e
Latina Oggi del gruppo di Ciarrapico), Giornale Nuovo della Toscana
(«testata distribuita esclusivamente in abbinamento con il quotidiano Il
Giornale»), Il Globo, Nuovo Oggi Molise (gruppo Ciarrapico),
Sportsman - Cavalli e Corse, Voce di Romagna…
Per il resto, si rilevavano due corposi contributi superiori al milione
e 800 mila (Il Sannio Quotidiano, «primo quotidiano di Benevento» e Rinascita). A
seguire il milione e 601 mila euro della Dolomiten di
Bolzano, il milione e 586 mila di Scuola Snals, il
milione e 406 mila di Nuovo Corriere Bari Sera, il
milione e 313 mila di Provincia Quotidiano di Frosinone,
il milione e 224 mila del Cittadino Oggi di Siena, il
milione e 185 mila della Verità, il milione e
272 mila della Voce di Mantova; i buoni piazzamenti,
sul milione di euro, dell’agenzia Area (storicamente legata
all’area ex PCI e fornitrice di decine di emittenti locali) e di Ottopagine
(«quotidiano dell’Irpinia a diffusione regionale» in vendita a 50 centesimi); i
916 mila euro di Dossier News di Caserta - Il
Giornale, gli 891 mila di Cronache del Mezzogiorno, i
753 mila dell’agenzia Dire.
Quotidiano, «primo quotidiano di Benevento» e Rinascita). A
seguire il milione e 601 mila euro della Dolomiten di
Bolzano, il milione e 586 mila di Scuola Snals, il
milione e 406 mila di Nuovo Corriere Bari Sera, il
milione e 313 mila di Provincia Quotidiano di Frosinone,
il milione e 224 mila del Cittadino Oggi di Siena, il
milione e 185 mila della Verità, il milione e
272 mila della Voce di Mantova; i buoni piazzamenti,
sul milione di euro, dell’agenzia Area (storicamente legata
all’area ex PCI e fornitrice di decine di emittenti locali) e di Ottopagine
(«quotidiano dell’Irpinia a diffusione regionale» in vendita a 50 centesimi); i
916 mila euro di Dossier News di Caserta - Il
Giornale, gli 891 mila di Cronache del Mezzogiorno, i
753 mila dell’agenzia Dire.
Una serie di testate venivano sostenute con un contributo annuo di 516
mila euro: Fare Vela, Luna Nuova, Carta,
Motocross, Il Mucchio Selvaggio («settimanale di musica rock,
cinema, libri e video»), La Nuova Ecologia di Legambiente, Rassegna
Sindacale («settimanale della CGIL specializzato sui temi del sindacato e
del lavoro»), Il Salvagente («settimanale dei diritti, dei consumi e
delle scelte» nato nel 1989 come supplemento all’Unità), Trenta Giorni nella
Chiesa e nel Mondo («mensile internazionale diretto da Giulio Andreotti»)…
A seguire, con contributi di minore entità, due mensili come Noi Donne
(storica rivista femminile nata nel 1937 a Parigi, espressione dell’UDI, Unione
Donne Italiane) e Minerva del Club delle Donne, l’associazione romana
guidata dall’ex PSI Annamaria Mammoliti, Chitarre del Musichiere Soc.
coop a r.l. e Jam «viaggio nella musica», testate come Metropolis
(quotidiano che «opera a partire dagli anni
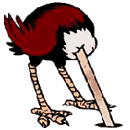 90
nell’area stabiese-sorrentina, tornese vesuviana, agro-nocerino-sarnese,
salernitano, avellinese»), il settimanale in sloveno Novi Matajur, il
«mensile di Agricoltura Alimentazione e Ambiente» Oep-Notiziario Agricolo
Spazio Rurale, Ore 12, Qui («settimanale di informazione
della Provincia di Ravenna»), il «settimanale di Imola» Sabato Sera, il
settimanale Sole delle Alpi che si propone di «far riscoprire le
culture locali, oramai vittime della globalizzazione culturale ed ideologica»,
il mensile Rivista Italiana Difesa «pubblicazione leader del settore in
Italia fin dal primo numero»...
90
nell’area stabiese-sorrentina, tornese vesuviana, agro-nocerino-sarnese,
salernitano, avellinese»), il settimanale in sloveno Novi Matajur, il
«mensile di Agricoltura Alimentazione e Ambiente» Oep-Notiziario Agricolo
Spazio Rurale, Ore 12, Qui («settimanale di informazione
della Provincia di Ravenna»), il «settimanale di Imola» Sabato Sera, il
settimanale Sole delle Alpi che si propone di «far riscoprire le
culture locali, oramai vittime della globalizzazione culturale ed ideologica»,
il mensile Rivista Italiana Difesa «pubblicazione leader del settore in
Italia fin dal primo numero»...
Chiudevano questa categoria i sei contributi più modesti,
elargiti a Lucania, «quotidiano di vita regionale» della Basilicata con
redazione, società editrice, centro stampa, concessionaria locale e
concessionaria nazionale a Bari, capoluogo della Puglia (153 mila euro);
all’Umanità, presumibile erede della vecchia testata socialdemocratica
(114 mila euro); al Quotidiano di Sicilia, «regionale
di Economia Istituzioni Ambiente Lavoro Impresa Terzo settore» (108 mila);
al quotidiano Domani di Bologna (76 mila); a Mari
e monti (84 mila) e al «settimanale d’informazione di
Anzio e Nettuno» Il Granchio (41 mila).
In questa categoria convergevano le quattro sottocategorie previste dall’art. 3
della legge 250 del 1990. Nel 2004 essa sarà, negli elenchi ufficiali del
Dipartimento, divisa in quattro capitoli: ventiquattro quotidiani editi da
cooperative, per complessivi 31 milioni 812 mila euro; quindici
quotidiani di società «la cui maggioranza del capitale sia detenuta da
cooperative, fondazioni ed enti morali», per complessivi 38 milioni 91
mila euro; quattro quotidiani editi in regioni di confine, per
complessivi 5 milioni 328 mila euro; cinque quotidiani editi e
diffusi all’estero, per complessivi 8 milioni 162 mila euro;
ventitré periodici editi da cooperative di giornalisti, per complessivi
9 milioni 613 mila euro. In tutto, tre testate in più rispetto alle 68
del 2002, per un totale esborso di circa 95 milioni di euro."Beppe
Lopez, La Casta dei giornali, ed. Nuovi Equilibri
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Carta dei Regimi di aiuto
E' importante concentrarsi
sulla qualità della spesa
di Nino D'Agostino*
su La Gazzetta del mezzogiorno
La Basilicata sulla carta appare regione virtuosa, di fatto
resta ancorata ad una pesante condizione di sottosviluppo, viene beffata da una
misura inadeguata, si trova a dover disporre di minori risorse comunitarie per
il periodo 2007-2013, aggiungendo un altro tassello al mosaico delle difficoltà
che dovrà fronteggiare nel prossimo futuro.
In sostanza la Basilicata dal fatto che a livello europeo
la contabilità delle risorse disponibile ruoti intorno al Pil riceve una doppia
penalizzazione: una di tipo metodologico, ossia il criterio di calcolo che non è
sintomo di buona salute della società, una seconda di natura sostanziale, che
concerne la valutazione effettiva statistica del Pil che sfugge alla concreta
realtà della ricchezza prodotta in regione. Ed esce dall’obiettivo 1 in un
momento molto delicato, certamente più complesso e difficile rispetto a qualche
decennio addietro: ai problemi economici strutturali, notoriamente
caratterizzati da livelli di produttività del lavoro alquanto inferiori agli
altri settori di attività, il nanismo imprenditoriale che investe oltre il 95%
delle imprese regionali, la scarsa dotazione infrastrutturale, ne occorre
aggiungere di nuovi.
Ci si riferisce, in particolare, alla pesante crisi di
larghi settori industriali, alla ripresa della emigrazione che interessa, come è
noto, soprattutto giovani altamente qualificati, al conseguente sfilacciamento
del tessuto demografico regionale, ai fenomeni di concentrazione del credito che
di fatto hanno svuotato la Basilicata di una sua presenza diretta nel mondo
bancario. Come fronteggiare questa nuova situazione? La prima cosa che sorge
spontanea è che è inutile fasciarsi la testa prime di essersela rotta.
Ci saranno comunque risorse disponili.
Sarà importante concentrare l’attenzione sulla qualità
della spesa, facendo tesoro dei parziali risultati fin qui raggiunti. In soldoni,occorre
programmare meglio i fondi Por 2007-2013, procedendo ad innovazioni progettuali
e procedurali sostanziali, individuando puntuali azioni di monitoraggio e
valutazione dei fondi già utilizzati, facendo il punto quindi sui risultati
conseguiti nel periodo 2000-2006, operazione in corso, ma che occorre
analizzare, allorché i dati saranno disponibili, con la lente di ingrandimento,
evitando autoreferenzialità controproducenti. In secondo luogo occorre
determinare maggiori sinergie tra politica e mondo economico e sindacale, dando
maggiore plasticità alla concertazione, basandola su progetti operativi, più che
su dichiarazioni di intenti, come molte volte è accaduto in passato.
La terza questione riguarda la Pubblica Amministrazione: si
impone una azione energica di riforma della sua organizzazione, delle procedure
amministrative connesse, ambiti questi che, se snelliti, possono contenere i
costi delle aziende in modo considerevole, rendendole maggiormente competitive.
* economista
_________________________________________________________________________________________________________________
Nucleare lucano e misteri italiani
di Giovanni Rivelli, La Gazzetta del
Mezzogiorno
 Che
fine hanno fatto quei 23 fusti di «rifiuti radiottivi» risultati mancanti all’Itrec
di Rotondella secondo quanto emerso in un’ispezione del 1982 finita in un’i n ch
i e s t a della Procura di Matera? Da dove sono partiti, e per decisione di chi,
le forniture di uranio di cui si parla in un documento della Cia di recente
descretato dalla Casa Bianca e nel quale si descrive come nel '79 e nel '82 «la
Snia-Techint, attraverso il Cnen» effettuò tre vendite al regime di Saddam
Hussein, che intendeva dotarsi di armamenti atomici?
Che
fine hanno fatto quei 23 fusti di «rifiuti radiottivi» risultati mancanti all’Itrec
di Rotondella secondo quanto emerso in un’ispezione del 1982 finita in un’i n ch
i e s t a della Procura di Matera? Da dove sono partiti, e per decisione di chi,
le forniture di uranio di cui si parla in un documento della Cia di recente
descretato dalla Casa Bianca e nel quale si descrive come nel '79 e nel '82 «la
Snia-Techint, attraverso il Cnen» effettuò tre vendite al regime di Saddam
Hussein, che intendeva dotarsi di armamenti atomici?
E questi misteri si legano
agli altri degli stessi anni, come l’ab - battimento del DC9 dell’Itavia ad
Ustica, il giro di commesse tra paesi europei per costruire pezzi del
supercannone europeo, alcune morti sospette, e un vorticoso giro di denaro di
cui pure si parla nell’inchiesta materana? Anche se, per alcuni, una
ricostruzione esiste, l’interrogativo è d’obbligo se è vero, come è vero, che
oggi verità sull’insieme di questa complessa materia, dai rifiuti radioattivi al
traffico di armi, la chiede un «Comitato per la verità sui traffici nazionali e
internazionali di rifiuti e materiali radioattivi», che, con Legambiente, vede
tra i suoi promotori proprio quel Nicola Maria Pace che da Procuratore Capo
aMatera indagando su un incidente alla Trisaia si trovò a confrontarsi con
questi scenari.
Un’inchiesta conclusa
(prima che Pace venisse trasferito a Trieste) sul solo versante degli incidenti,
lasciando, evidentemente, irrisolti tanti dubbi.
RIFIUTI E ARMI NUCLEARI -
Dubbi che partono proprio dal rapporto scorie-nucleare bellico. Perchè il
riprocessamento di scorie che doveva essere fatto a Rotondella per alimentare un
programma nucleare civile da 20mila megawatt (che gli Usa avrebbero finanziato
in Italia con 9mila e 600 miliardi di lire tramite la Eximbank prevedendo anche
spese in Paesi terzi) era in grado di produrre plutonio, utile a fini militari.
Un particolare già noto nel 1978. In una riunione sulle intese con gli Usa che
si tenne al Ministero degli Esteri il 30 marzo di quell’anno, i tecnici
avvertirono che «con il ciclo “T hrow-away” si costituiscono vere miniere di
plutonio che con il tempo diventano sempre più accessibili».
LE «DISTRAZIONI» DELL’ITREC
- Una materia delicata che, però, alle risultanze dell’in - chiesta materana,
non avrebbe visto all’I t re c una corrispondente attenzione, al punto che una
perizia chiesta fatta effettuare anche per far luce sulla presenza di fusti
nello stabilimento afferma che «il capitolo dei rifiuti di provenienza esterna
immagazzinati nell’a re a Itrec, parafulmini radioattivi, rifiuti biomedicali,
oltre a sorgenti ormai decadute, è certamente il più oscuro nella storia del
centro, come testimoniano numerosi documenti e atti ». «Il contenuto di
radioattività di questi rifiuti e la loro provenienza - continuano i consulenti
- non sempre sono rilevabili dagli incompleti documenti disponibili. Sembra di
poter al riguardo affermare che il loro ingresso nel centro non fu a suo tempo
registrato con l’attenzione che avrebbe meritato». E col tempo, ci sarebbero
state anche procedure diverse. «La vigilanza - scrive il responsabile del
servizio alla Procura di Matera dopo un cambio di procedure avvenuto nel 1993 -
non è in grado di sapere quale è il tipo di materiale così come denunciato in
arrivo, nè custodisce più i relativi permessi e bolle di accompagnamento». E un
altro addetto alla vigilanza parla di 11mila piccoli fusti «fuori contabilità»
seppelliti in una fossa a ridosso dell’Itrec e poi rimossi. U n’area in cui,
precisa il vigilante «non era previsto ed anzi era vietato qualsiasi tipo di
controllo dai parte del servizio di vigilanza sulle autovetture private del
personale in entrata o in uscita dal centro» I
SOSPETTI SU ARMI E RIFIUTI
NUCLEARI - «Il sospetto che emerge dalle indagini della magistratura e delle
Commissioni parlamentari d’inchiesta sui traffici di rifiuti - dice oggi Enrico
Fontana, responsabile dell’Osservato - rio nazionale ambiente e legalità di
Legambiente - è che lungo le rotte internazionali dei rifiuti tossici viaggino
sovente anche armi e munizioni». Parole che assumono una chiara chiave di
lettura alla luce della emissione da parte della Direzione distrettuale
antimafia di Potenza di 10 avvisi di garanzia a otto ex direttori del centro
Enea di Rotondella e a due boss della ‘ndrangheta con l’accusa di «produzione
clandestina di plutonio, traffico di sostanze radioattive e violazione dei
regolamenti per la custodia di materiali e scorie nucleari». Un punto di svolta
l’inchiesta di Potenza, per provare a forare quello da subito apparso come un
«muro di gomma», ma non una novità. Nell’inchiesta di Matera già compare
l’ipotesi di traffici di materiale nucleare e c’è chi parla anche di fini
militari. In verità si tratta di atti che vengono riversati nel fascicolo lucano
partendo da un’altra inchiesta quella condotta a Venezia dal Pm Felice Casson,
il magistrato che ha indagato su «Gladio» e le reti di difesa «sotterranee»
dell’occidente nel periodo della guerra fredda. A parlare è una giornalista che
si dice in contatto con un «supertestimone» di Gladio e riferisce di aziende che
«userebbero sistemi di copertura per traffici illeciti verso paesi soprattutto
soggetti all’embargo». Nel verbale, redatto il 12 luglio del 1995, e quindi ben
prima che emergessero le notizie su un possibile «affaire nucleare lucano», si
parla in particolare di realtà «coinvolte nel riarmo dell’Irak, le quali
effettuano questo tipo di attività in particolar modo dall’Italia». Si fa
riferimento ad alcune società «coinvolte nel traffico del nucleare» e ad
«aziende militari elettroniche specializzate anche in controlli elettronici di
armi ed impianti nucleari».
IRAK, PAKISTAN E MOSSAD
TRA ARMI E URANIO - In un caso c’è una «coincidenza di nome: Bull, come Gerald
Bull, un cittadino americano dell'Ontario che lavorava per il supercannone di Saddam
Hussein. Venne ritrovato morto in Belgio nel marzo 1990. L'assassinio non è
ancora risolto ma funzionari della Cia affermano che con molta probabilità il
Mossad, il potente servizio segreto israeliano, ne era coinvolto nell’ambito
delle sua nuova strategia di colpire quanti collaboravano con chi minacciava la
sicurezza dello Stato di David anche oltre i propri confini. E siamo ad un nuovo
punto cruciale. Perchè se è certo che a Rotondella arrivarono tecnici sia
pakistani (Paese che ha completato da un decennio il suo processo per giungere
all’ato - mica) che iracheni, secondo la Cia, il 12 dicembre del 1979,
dall’Italia sono partiti tre carichi: uno di diossido d’uranio depleto (6.005
kg), e due di diossido d’uranio naturale, per complessivi 4.506 chili. Poi, il
18 maggio del 1982, sono stati inviati «1.767 kg di diossido d’uranio a basso
livello d’arricchimento». Ma non una parola su come questi materiali siano stati
inviati, anche se certamente non c’è da attendersi che siano stati soggetti a
regolare movimentazione.
cittadino americano dell'Ontario che lavorava per il supercannone di Saddam
Hussein. Venne ritrovato morto in Belgio nel marzo 1990. L'assassinio non è
ancora risolto ma funzionari della Cia affermano che con molta probabilità il
Mossad, il potente servizio segreto israeliano, ne era coinvolto nell’ambito
delle sua nuova strategia di colpire quanti collaboravano con chi minacciava la
sicurezza dello Stato di David anche oltre i propri confini. E siamo ad un nuovo
punto cruciale. Perchè se è certo che a Rotondella arrivarono tecnici sia
pakistani (Paese che ha completato da un decennio il suo processo per giungere
all’ato - mica) che iracheni, secondo la Cia, il 12 dicembre del 1979,
dall’Italia sono partiti tre carichi: uno di diossido d’uranio depleto (6.005
kg), e due di diossido d’uranio naturale, per complessivi 4.506 chili. Poi, il
18 maggio del 1982, sono stati inviati «1.767 kg di diossido d’uranio a basso
livello d’arricchimento». Ma non una parola su come questi materiali siano stati
inviati, anche se certamente non c’è da attendersi che siano stati soggetti a
regolare movimentazione.
USTICA E L’URANIO ALL’I R
AQ - Un fatto questo che rimanda ad un altro dei misteri italiani,
l’abbattimento del Dc 9 Itavia ad Ustica. Alle 20 e 59’ del 27 giugno 1980 l’a e
re o esplode in volo nel cielo della Sicilia causando 81 vittime. Arriva la
rivendicazione del gruppo terroristico dei Nar, ma i giudici la classificheranno
come un vero e proprio depistaggio operato dal cosidetto Super Sismi, una
«cupola » dei servizi segreti inquinati dalla P2. Nella stessa notte cade sui
monti della Sila anche un Mig libico. Mario Alberto Dettori, radarista della
base di Poggio Ballone, vicino a Grosseto, (poi morto suicida) confessa alla
moglie: «Quella notte è successo un casino, per poco non scoppia la guerra». E
una verità su quella storia la forniscono, nel febbraio 1994 Claudio Gatti e
Gail Hammer, autori di un libro inchiesta (Il quinto scenario, edito da Rizzoli).
Il DC9, sostengono fu abbattuto per sbaglio dai servizi segreti israeliani che
volevano colpire un aereo che trasportava uranio arricchito destinato a una
centrale nucleare irachena. Un intreccio di fatti e misteri, per qualcuno
collegati, per altri no, che testimonia di certo un indifferibile bisogno di
chiarezza su una serie di vicende di cui «l’affaire nucleare» pare essere
sicuramente un perno.
_____________________________________________________________________________________________________________
Milioni di euro sulla panchina
 Inchiesta
sui dati del programma operativo Val D'Agri attuato con i fondi del petrolio
Inchiesta
sui dati del programma operativo Val D'Agri attuato con i fondi del petrolio
di Giovanni Rivelli da La Gazzetta del
Mezzogiorno
Qualche programma da
rivedere, qualche attività produttiva da eliminare, qualche problema e qualche
rischio per l'ambiente. ma il Petrolio della Val d'Agri doveva essere
l'opportunità di sviluppo per una delle aree interne dell Basilicata. La parola
magica era «royalty» ossia quelle quote di ricavo dall'attività estrattiva che
le compagine devolvono agli enti locali. Ma dall'utilizzo fatto di questa
consistente massa di denaro, iniziative in grado di portare occupazione e
sviluppo duraturo non se ne vedono tantissime. La voce più consistente di quella
massa di euro è quella che è stata gestita direttamente dalle amministrazioni
comunali. Si tratta di 146 milioni di euro programmati (!'intero piano operativo
conta su 350 milioni) e ben 97 milioni sono già stati impegnati nei programmi
predisposti dalle 30 amministrazioni comunali coinvolte.
PANCHINE E MARCIAPIEDI
Delle somme finite ai Comuni oltre la metà, e cioè 51 milioni e passa di euro,
sono stati investiti (si fa per dire) in piazzette, panchine, arredi urbani,
fontane monumentali, tavoli di pic nic, sentieri naturali e opere del genere,
come è visibile nel dettaglio a . fianco. Indubbiamente i paesi del petrolio
sono più belli. Ma è difficile pensare che i 900mila euro per sistemare piazza
Zecchettin di Marsicovetere o le centinaia di migliaia di euro spese in arredi
urbani (panchine fioriere e simili) a Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello,
Guardia Perticara, Satriano, San Martino d'Agri, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso
di Castalda e Tramutola (solo per citare quelli che hanno previsto poste
dedicate senza confonderle nel più generale «recupero») possano dare lavoro a
qualcuno al i là di chi ha fornito e posto in opera questi beni e limitatamente
al periodo di fornitura.
SOLDI AI CITTADINI - Paesi
più belli, insomma, è più sicuri. Perchè andando ancora a segmentare la spesa
dei Comuni si scopre che al secondo posto per «peso» c'è un altro capitolo con
sui le amministrazioni hanno inteso dare «dividendi» direttamente ai cittadini.
Le linee di spesa, che interessano molti centri (come meglio spiegato nel pezzo
sotto) sono tre e cioè J progetti «riqualificazione formale facciate e
coperture», «casa sicura» e «box interrati». A queste attività sono finiti
qualcosa come 14 milioni di euro. E se sette comuni (almeno per il momento) non
hanno destinato a questa voce nemmeno un euro, c'è anche chi, è il caso di
Viggiano, ha deciso investire così qualcosa come 2 milioni e 300 mila euro,
quasi la metà del proprio programma royalty (circa 5 milioni e mezzo).
LUDOTECHE E CENTRI ANZIANI
- Fortunati, insomma, quanti risiedono nei paesi del petrolio. Anche perchè la
loro vita migliora. Oltre 13 milioni e mezzo sono finiti ai programmi «socio
assistenziali», realizzazione di centri per anziani, ludoteche e simili. E
qualcuno va anche oltre. il Comune di Gorgoglione in queste spese inserisce
190mila euro per riqualificare il vecchio cimitero. UN
AIUTO ALLO SPORT - A poca
distanza, in termini di spesa, le somme destinate allo sport. Qui i milioni
spesi sono dodici e, a meno di non candidarsi per le prossime olimpiadi,
benefici ce ne saranno sulla qualità della vita, ma non certo sullo sviluppo.
Difficile, infatti, pensare che i 428mila euro spesi dal Comune di Brienza per
mettere il manto di erba sintetica allo stadio e fare la copertura alla tribuna
possano produrre un posto di lavoro stabile. E i campi da bocce finanziati a
Gallicchio. Gorgoglione, il campo di tiro a volo fatto a Paterno, o la pista di
kart di Laurenzana produrranno redditi più che (nel migliore dei casi) per
qualche custode.
CAMPAGNE CENERENTOLA - In
questa massa di spesa, la maggiore «parsimonia» è riservata alle campagne. Per
quelle opere classificate come «di civiltà rurale» ben 8 centri (Abriola,
Montemurro, San Martino D'Agri, Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, Satriano,
Spinoso e Viggiano) non spendono nulla e gli altri in totale ci mettono 5
milioni e 800mila euro, un decimo, insomma, di quanto speso in panchine e
piazzette. Eppure si tratta di strade, acquedotti, reti elettriche, e via
dicendo, queste si che possono servire a sostegno di un' economia agricola
(difficile che senza acqua e luce qualcuno resti a coltivare i campi). E, da
questo quadro, le uniche alternative offerte sono di giocare a bocce, andare in
ludoteca o al centro anziani.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
"Qui i Fondi Ue diventano un freno"
L’on. Cappato (Radicali) attacca la gestione degli aiuti in
Basilicata. «Illeciti o comunque sprechi»
di Giovanni Rivelli, da La Gazzetta del Mezzogiorno
"Certo non bisogna generalizzare. Ma quando i fondi europei
in Basilicata sono impiegati senza un ritorno è uno spreco, quando finiscono
addirittura con l’alimentare gli illeciti diventano addirittura dannosi per la
crescita dell’economia locale perchè finiscono col danneggiare chi fa le cose
per bene. Ed è il caso della Basilicata». Marco Cappato, eurodeputato radicale
eletto nella Lista Bonino, continua a puntare il dito contro la gestione dei
fondi Ue nella nostra Regione. Questa volta lo fa con un elemento in più: la
risposta a una interrogazione giunta 24 ore prima dalla Commissione europea. «La
precisazione dell’onorevole deputato riguardo il crescente numero di
irregolarità segnalate - si legge nel documento della Commissione - è fondata:
nel solo anno 2006, infatti, in Basilicata sono state riscontrate 80
irregolarità e ben 79 di queste sono state classificate dalle autorità italiane
come presumibilmente fraudolente, per un importo stimato a circa 3,7 milioni di
euro». «Chiaramente - riprende oggi il parlamentare - il problema non è
eliminare i fondi europei, ma migliorarne la gestione. E accorgersi che qualcosa
non va non è difficile. Noi in Basilicata non abbiamo una struttura, ma solo un
attivista, Maurizio Bolognetti che con gli strumenti che ha un semplice
cittadino tira fuori i casi che poi io porto al Parlamento Europeo. Se un
semplice cittadini si rende conto che qualcosa non va, ancor più potrebbe farlo
chi ne ha gli strumenti. E ancor più - aggiunge - la cosa si vede sui dati
sociali: la spesa dei fondi europei ha un ritorno minimo su quello che potrebbe
essere lo sviluppo. E questo lo dice anche la Corte dei Conti». L'ammontare
complessivo dei fondi strutturali concessi alla regione Basilicata per il
periodo di programmazione 2000-2006 è consistente. Si tratta di oltre 848
milioni di euro. Al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sono finiti
433milioni , ossia il 51,16% del totale, mentre al Fondo sociale europeo (FSE) e
al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Orientamento (FEAOG) sono
stati destinati rispettivamente 220 milioni (26,05%) e 193 milioni (22,79%). E
proprio su quest’ultimo capitolo, a quanto ha riferito la Commissione, ci
sarebbero state il maggior numero di irregolarità. «Evidentemente - riprende
l’eurodeputato radicale - c’è un problema e c’è un problema forze anche nelle
relazioni impresa-politica-giustizia. E a questo problema dovrebbe rimediare
l’Unione Europea con controlli più stringenti. Se un’istituzione è incapace di
autogovernarsi e autocontrollarsi, l’Ue dovrebbe intervenire. E poi sarebbe
necessario dare massima pubblicità d ogni singolo finanziamento perchè se i
cittadini sanno esattamente a cosa vengono destinati i soldi sono i primi a
poter segnalare ciò che non va. Un po’ di tempo fa mi occupai di un corso di
formazione finanziato in Basilicata. Doveva formare autoriparatori, ma il
tirocinio era fatto in un autolavaggio. Sulle carte di parla genericamente di
una ditta, ma chi è del posto si rende conto che nella realtà è un assurdo "
______________________________________________________________________________________________________________________________________
La fame di pancia e di giustizia
di Mimmo Sammartino
Pane e veleni. Pane venduto a peso d’oro. Pane che costa
più del companatico. Tracce di una economia che separa sempre più l’interesse
dal bisogno. A sentire i consumatori e il coordinatore regionale Anci per i
piccoli Comuni, Nicola Valluzzi, si tratta di aumenti scandalosi avvenuti senza
argomenti plausibili. Non regge neppure la motivazione dell’incremento del
prezzo della farina. Una impennata che segna un cambiamento anche di mentalità e
di relazione con il consumo: pare la dichiarazione che neppure il pane può
essere più ritenuto un bene di prima necessità. Un bene essenziale che dev’essere
alla portata di tutti: anche di quelli che, con il magro reddito di cui
dispongono, reggono a stento l’impatto con la quarta settimana del mese. Fa
impressione anche il fatto che nessuno (o quasi) abbia sino ad ora gridato allo
scandalo per la china assunta dagli eventi. Bisognerà inventare una
riproposizione dei vecchi «panieri»: quelli che garantivano il prezzo
accessibile per i beni considerati necessari. E però, al posto di pane e pasta,
bisognerà proprio decidersi a ficcarci dentro salmone e brioches. È tempo di
letture sempre più rare.
E dunque sono già dimenticate le pagine manzoniane
dell’assalto ai forni. Sarà questione di fame il cui confronto - fra quell’epoca
e quella del nostro tempo - il confronto non regge. Oggi in fondo anche la fame
ha cambiato di segno nella società delle opulenze e delle povertà. Chi la prova,
tende a viverla in silenzio e anche con un po’ di vergogna. E poi la fame ha
assunto diverse facce. C’è fame di autonomia e di indipendenza. C’è diffusa fame
di lavoro. C’è fame di giustizia e verità in un Paese che non sempre sriesce a
garantirle. Per quest’ultima fame ieri è arrivato un segno.
Gli uomini della polizia, su disposizione della Procura
della Repubblica di Salerno, hanno scandagliato - con l’ausilio di nuovi
strumenti tecnologici - i luoghi che, una domenica di settembre lontana ormai 14
anni fa, videro passare Elisa Claps, la sedicenne potentina da allora scomparsa
nel nulla. Se queste ricerche consentiranno di dipanare quel mistero, se
aiuteranno a fare verità, porteranno consolazione alla famiglia di Elisa e anche
a tutti gli altri che, nonostante il tempo trascorso, restano affamati di
giustizia.
da La Gazzetta del Mezzogiorno
____________________________________________________________________________________________________________________
Storia della
Basilicata che si muove
Cronologia degli ultimi
mesi
La Basilicata è oggi, come
mai è accaduto in passato, al centro dell’attenzione della stampa nazionale.
Il Corriere della Sera
del 26 febbraio 2007 scrive: “I danni si stanno quantificando in Calabria, ma
l’epicentro di questo terremoto è in Basilicata. Ed è il sisma più grave
dell’ultimo quarto di secolo, dopo quello del 1980, perché è il più terribile
esempio della rottura del «patto» tra cittadini e istituzioni, tra governati e
governanti, senza il quale non si va da nessuna parte. Il mito della Lucania
Felix, semmai avesse un fondamento, è finito. Non regge più. Nemmeno come
espediente mediatico. Lo dicono i fatti sui quali sta indagando la procura di
Catanzaro, che ha messo sotto inchiesta i vertici della magistratura lucana,
alti gradi delle forze dell’ordine, politici e funzionari pubblici, tutti
indagati per gravissimi reati: truffa e corruzione, anche in atti giudiziari,
falso e abuso d’ufficio, anche a fini patrimoniali, appropriazione indebita”.
La storia degli ultimi
mesi può aiutare a capire che cosa sta accadendo in Basilicata e come in questa
piccola regione emerga finalmente il desiderio di riscattarsi da una sorta di
maledizione che spinge i giovani ad un bivio: imparare a muoversi tra amicizie e
favori o partire al più presto per non rinunciare ai propri sogni.
Qualcosa si muove oggi in
Basilicata, qualcosa comincia ad unire i cittadini che in questi anni hanno
inventato, ciascuno per proprio conto, forme di resistenza, ma anche cittadini
stanchi di tenere la testa bassa e di trasmettere ai propri figli quella triste
saggezza del “mai nulla cambierà”, quasi un codice genetico della rassegnazione.
Qualcosa si muove in
Basilicata, se è vero che oggi tante persone si ritrovano insieme per gridare
che la verità non dovrà rimanere nascosta, per raccogliersi intorno a chi questa
verità l’attende da anni: i familiari di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, di
Elisa Claps, di Giovanni De Blasiis, di Vincenzo De Mare. Qualcosa si muove,
proprio a partire da queste ed altre storie di morti ammazzati, di strani
suicidi, di persone scomparse, di coperture e depistaggi.
La storia degli ultimi
mesi è la storia di questa Basilicata che s’indigna e che si ritrova. È la
storia dei tanti cittadini che finalmente hanno deciso di non lasciare più sole
le vittime, è la storia di questa piccola terra che ha ancora davanti a sé un
futuro incerto, ma che ha deciso di mettersi gioco, a partire dalla dignità dei
cittadini liberi.
Gli appelli, le assemblee,
gli incontri, sono solo una parte di un cammino che è fatto ancora, ed in gran
parte, del silenzio operoso e dell’impegno dei tanti cittadini onesti. L’intento
è però quello di far emergere il bisogno di giustizia e verità, sostenendo un
radicale cambiamento culturale e di prospettiva.
La cronologia degli
ultimi mesi mostra come questi nuovi percorsi stiano prendendo forma nei volti
di donne e uomini che si incontrano, si parlano, scoprono di non essere soli
nella ricerca della verità:
AMARO LUCANO – ottobre
2006
Nel mese di ottobre 2006,
quarantuno cittadini lucani hanno tappezzato i muri della città di Potenza con
un articolo di Marco Travaglio, che descriveva lo stato della giustizia in
Basilicata e gli intrecci tra magistrati e politici. L’intento dell’iniziativa
era quello di aprire una breccia nella cappa di silenzio che da sempre copre,
zittisce, protegge la cosiddetta “isola felice”. Ed era anche quello di
testimoniare, con nomi e cognomi, che la paura o la convenienza non aiutano e
che la verità è l’unica speranza di futuro se si aspira ad un futuro da
cittadini liberi.
NOI CITTADINI LUCANI – 27
marzo 2007
Martedì 27 marzo 2007
circa 150 cittadini lucani acquistano 2 pagine a pagamento del Quotidiano della
Basilicata per esprimere stima e solidarietà ai magistrati Iannuzzi, Woodcock e
Montemurro e per proteggerli dai continui tentativi di delegittimarne l’azione.
Nei giorni di Vallettopoli il fatto ha una notevole risonanza a livello
mediatico ed anche grazie al sostegno di Marco Travaglio e Beppe Grillo,
l’appello raggiunge quasi 30.000 adesioni in tutta Italia.
APPELLO PER IL pm DE
MAGISTRIS – aprile 2007
Il magistrato che conduce
l’inchiesta sulle toghe lucane e che, a partire da essa, tenta finalmente di
aprire squarci di verità sugli intrecci perversi tra politica, magistratura,
massoneria e criminalità organizzata, è il pm di Catanzaro Luigi De Magistris.
Si tratta dello stesso magistrato a cui è stata appena sottratta dal suo
procuratore capo l’importantissima inchiesta Poseidon, riguardante un ammanco di
oltre 200 milioni di euro nei fondi europei per la depurazione destinati alla
regione Calabria.
In tutta Italia, “facciamo
la scorta ai nostri giudici” è lo slogan proposto da Marco Travaglio, che ben
esprime l’idea di una società che protegge e sostiene quei magistrati che
lavorano senza timore in cerca della verità.
ASSEMBLEA PUBBLICA
con i familiari di LUCA ORIOLI e MARIROSA ANDREOTTA, ELISA CLAPS, VINCENZO DE
MARE, GIOVANNI DE BLASIIS – 27 aprile 2007.
“Abbiamo bisogno di fare
memoria di queste storie – le vostre come quelle di altri in Basilicata (penso
all’omicidio dello stesso avvocato Lanera) – ecco perché ci è indispensabile
sgranare il triste rosario di quei morti, fare chiaramente certi nomi e certi
cognomi, puntualizzare l’infinita serie di coincidenze che avvolge tanti
avvenimenti di questa nostra regione, ed ecco perché qualcuno si arrabbia solo
al ricordarle le vostre tragedie aggiungendo anche l’indecenza di dirvi che
dovete rassegnarvi: perché abbiamo l’impressione che possano essere proprio le
vostre storie a tracciare quei confini, ad aiutarci a capire le tante cose che
ancora non abbiamo capito della Basilicata e a dare un nome, i nomi, a quel
grumo di potere trasversale che sempre più abbiamo l’impressione che si muove
dietro le quinte di questa terra. Certo, non siamo qui per fare processi a
nessuno: non siamo qui contro qualcuno ma per qualcosa: la giustizia e la
verità.”
…
“Siamo qui stasera per
capire, per non farci più prendere in giro da nessuno, per rivendicare
l’intelligenza della verità contro l’offensiva arroganza della menzogna, per
reclamare il sacro diritto della giustizia, ma soprattutto per dire, per dirvi,
che in tutto questo avvertiamo forte nell’aria il sentore di una nuova stagione,
la positiva convergenza di quelle belle e faticose esperienze sociali,
culturali, politiche a cui apparteniamo e che vogliono condividere i sentieri
della ricerca della verità; percepiamo il prepotente desiderio di tanti di
mettersi in gioco e di provare a tracciare strade nuove.”
Dalla relazione
introduttiva dell’assemblea di don Marcello Cozzi, responsabile regionale di
LIBERA, coordinamento regionale di Basilicata.
INCONTRO dell’ASSOCIAZIONE
PENELOPE SUL CASO ELISA CLAPS “Ritessiamo la tela” – 12 maggio 2007.
“La più grande
punizione che i cattivi possano ricevere è quella di sentirsi controllati dagli
onesti” Stuart
Mill
Altre esperienze, altre
storie della Basilicata che si muove segneranno il cammino ed arricchiranno
questa cronologia, perché, come è stato ricordato nell’assemblea del 27 aprile,
“da oggi non si
torna più indietro”.
__________________________________________________________________________________________________________________
Christ still stops at Eboli.
Cristo ancora fermo ad Eboli
The Economist Agosto 2007
LE
SCORIE ATTO PRIMO -
Qualche tempo fa a
Scanzano Jonico, ridente cittadina marittima, un terremoto
giudiziario ha spazzato via i vertici amministrativi: 15 arrestati, fra cui il
sindaco, Mario Altieri (AN), il vicesindaco e l'assessore
all'Agricoltura. Le accuse, molteplici: innanzitutto i brogli elettorali
("In quella sezione mettimi tizio presidente. Hai anche i nomi degli
scrutatori", avrebbe detto Altieri) e, non meno importante,
l'intimidazione di alcuni giornalisti avvenuta nei mesi caldi della protesta
contro la famosa decisione del Governo di gettare anni di monnezza nucleare in
un sito turistico e geologicamente inadatto. In quell'occasione, una parte
importante la ebbe uno dei clan lucani cui probabilmente si riferisce l'Economist:
il clan Scarcia. Pare infatti che il sindaco si sia rivolto ad esponenti
dell'organizzazione per evitare le contestazioni (i dimostranti lo incolpavano
di essere "colluso" con la decisione governativa, anzi nei fatti di averla
favorita). Addirittura un giorno, uno degli arrestati - tale Giuseppe Pisanò
- fece irruzione nella sede del comitato "Scanziamo le scorie" - dove
Altieri si stava recando per un incontro - dicendo "Il sindaco va applaudito
e ringraziato per la riuscita della protesta e non contestato".
LE SCORIE ATTO SECONDO - Ben prima di questa ultima storia di scorie, però,
ce n'è un'altra che chiama in causa direttamente la 'ndrangheta. Si
tratta della misteriosa presenza di 100 fusti di materiale nucleare sotterrati
da qualche parte nell'entroterra lucano, la cui ricerca impegna carabinieri e
forze dell'ordine da anni. Dell'origine di queste scorie, si ha solo qualche
notizia nebulosa: si parla di ingegneri iracheni all'enea di
Rotondella e all'Itrac
di Trisaia e traffico di materiale nucleare dall'estero. Fattosta
che un giorno alla 'ndrangheta viene chiesto di
far sparire 600 fusti di materiale: 500 partiranno alla volta della
Somalia, di notte, mentre altri 100 resteranno qui, in Basilicata.
Da allora dormono, nascosti chissà dove, in una Regione in cui il tasso
di incidenza tumorale è misteriosamente schizzato malgrado "l'aria pulita" e "i
sani stili di vita", anche fra i giovanissimi. Anche fra i bambini. E da qualche
anno si inseguono questi mostri sepolti,
si gira come trottole dietro le dichiarazioni di un pentito
della malavita campana che ha indirizzato più volte gli investigatori verso
luoghi rivelatisi sbagliati. Una caccia alla bomba mortale che è arrivata anche
qui, a un chilometro scarso da dove ora sto scrivendo. E pensare che
qualcuno, l'Economist, voleva pure smentirlo.
________________________________________________________________________________________________________________
Bene o male la barca va ma
ci serve anche saperlo
di Giovanni Rivelli
Due amici si
incontrano. «Come va?» dice il primo. «Mi si è bruciata la casa - risponde
l'amico - ma l'assicurazione mi ha dato molto più di quel che valeva. Mia moglie
è morta, e ne ho sposato una più giovane, bella e ricca, ma poi mi ha lasciato.
L'azienda è fallita, ma per questo i creditori mi lasciano in pace e mio padre,
per aiutarmi mi ha dato una forte somma di denaro». «Insomma va bene o va male?»
ribatte l'interlocutore. «Va, caro amico, semplicemente va». La storiella
ebraica è una rappresentazione della vita che ben si adatta a molte circostanze.
La Sma manda le lettere di licenziamento, la Itl avvia le procedure di
assunzione. Trenitalia a Melfi riduce gli organici all'osso, Acquedotto Lucano
rilancia gli investimenti. Insomma, come va bene o male? Il problema è questo.
Capire come va e, al di là di questo, se si può far qualcosa perchè vada meglio.
L'opposizione regionale ha posto un problema, quello del controllo sull'azione
amministrativa, che riguarda tutti a partire dai cittadini-elettori. Serve uno
sforzo di trasparenza, che non è sinonimo di onestà (quella, fino a prova
contraria, non la si mette in dubbio per nessuno) ma vuol proprio dire far
capire dal di fuori quello che si sta facendo dal di dentro. Diversamente anche
il dibattito politico si riduce a «tifoseria», anzi a «fede». Nella scorsa
consiliatura si parlò molto di riforma dello Statuto regionale. Venne varata
un'apposita commissione, presieduta da un esponente dell'opposizione, ma alla
fine non ci fu un accordo e nessuna proposta fu approvata. Il dibattito si
incentrò più sul numero dei consiglieri e sui sistemi di elezione che non sui
meccanismi di funzionamento. Poi il discorso è caduto. Per rilanciare la
«trasparenza» si può ripartire da qui. Diversamente si rischia di restare solo
con polemica e fumo. E il fumo ha solo l'effetto, e spesso lo scopo, di far
vedere ancor meno di prima.
La Gazzetta
del Mezzogiorno del 13-09-06
Per chi non lo avesse ancora
letto vi propongo il tanto discusso editoriale di Mieli sul Corriere della Sera
dell'8 Marzo 2006. Cosa ne pensate?
La
scelta del 9 aprile
Paolo Mieli
A dispetto di quel che da
tempo attestano, unanimi, i sondaggi, il risultato delle elezioni che si
terranno il 9 e 10 aprile appare ancora quantomai incerto. È questo un buon
motivo perché il direttore del Corriere della Sera spieghi ai lettori in modo
chiaro e senza giri di parole perché il nostro giornale auspica un esito
favorevole ad una delle due parti in competizione: il centrosinistra. Un
auspicio, sia detto in modo altrettanto chiaro, che non impegna l’intero corpo
di editorialisti e commentatori di questo quotidiano e che farà nel prossimo
mese da cornice ad un modo di dare e approfondire le notizie politiche quanto
più possibile obiettivo e imparziale, nel solco di una tradizione che compie
proprio in questi giorni centotrent’anni di vita.
La nostra decisione di dichiarare pubblicamente una
propensione di voto (cosa che abbiamo peraltro già fatto e da tempo in
occasione delle elezioni politiche) è riconducibile a più di una motivazione.
Innanzitutto il giudizio sull’esito deludente, anche se per colpe non tutte
imputabili all’esecutivo, del quinquennio berlusconiano: il governo ha dato
l’impressione di essersi dedicato più alla soluzione delle proprie
controversie interne e di aver badato più alle sorti personali del presidente
del Consiglio che non a quelle del Paese. In secondo luogo riterremmo nefasto,
per ragioni che abbiamo già espresso più volte, che dalle urne uscisse un
risultato di pareggio con il corollario di grandi coalizioni o di soluzioni
consimili; e pensiamo altresì che l’alternanza a Palazzo Chigi - già
sperimentata nel 1996 e nel 2001 - faccia bene al nostro sistema politico. Per
terzo, siamo convinti che la coalizione costruita da Romano Prodi abbia i
titoli atti a governare al meglio per i prossimi cinque anni anche per il modo
con il quale in questa campagna elettorale Prodi stesso ha affrontato le
numerose contraddizioni interne al proprio schieramento. Merito, questo,
oltreché di Romano Prodi, di altre quattro o cinque personalità del
centrosinistra. Il leader della Margherita Francesco Rutelli, che ha saputo
trasformare una formazione di ex dc e gruppi vari di provenienza laica e
centrista in un moderno partito liberaldemocratico nel quale la presenza
cattolica è tutelata in un contesto di scelte coraggiose nel campo della
politica economica e internazionale. Piero Fassino, l’uomo che più si è speso
per traghettare, mantenendo unito e forte il suo partito, la tradizione
postcomunista nel campo dominato dai valori di cui sopra. I radicalsocialisti
Marco Pannella e Enrico Boselli che con il loro mix di laicismo temperato e
istanze liberali rappresentano la novità più rilevante di questa campagna
elettorale. Fausto Bertinotti, il quale per tempo ha fatto approdare i suoi
alle sponde della nonviolenza e ha impegnato la propria parte politica in una
nitida scelta al tempo della battaglia sulle scalate bancarie (ed editoriali)
del 2005. Noi speriamo altresì che centrosinistra e centrodestra continuino ad
esistere anche dopo il 10 aprile. E ci sembra che una crescita nel
centrodestra dei partiti guidati da Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini
possa aiutare quel campo e l’intero sistema ad evolversi in vista di un futuro
nel quale gli elettori abbiano l’opportunità di deporre la scheda senza vivere
il loro gesto come imposto da nessun’altra motivazione che non sia quella di
scegliere chi è più adatto, in quel dato momento storico, a governare. Che è
poi la cosa più propria di una democrazia davvero normale
08 marzo 2006
Un treno
pulito è anche questione di democrazia
di MICHELE PARTIPILO 15/01/2006
La Gazzetta del Mezzogiorno
 È singolare come, in una
società che vive di comunicazione, per certe categorie sociali
sia sempre più difficile comunicare. E lo diciamo ricordando che
questa parola ha numerosi significati: da quelli più astratti a
quelli più concreti, addirittura fisici. C'è allora una
comunicazione che avviene attraverso giornali, radio,
televisione, internet, posta e c'è una comunicazione che avviene
attraverso strade, aeroporti e ferrovie. Storicamente la
comunicazione è sempre stata uno strumento di potere: chi
gestiva più notizie o aveva più mobilità riusciva a dominare gli
altri. La tanto celebrata lungimiranza di certi personaggi del
passato - da Cesare allo stesso Federico II - per quanto
lodevole, non è mai disgiunta dall'affermazione e dalla gestione
del potere. Le famose strade consolari romane sono state uno
strumento fondamentale per far funzionare l'impero. Così come le
aperture e gli scambi culturali del Grande Tedesco non sono
stati certo ininfluenti sulla tenuta del suo regno. È solo con
l'avanzata dei regimi democratici che i mezzi di comunicazione
perdono il vestito autoritario e assumono una dimensione di
servizio verso la società. Una buona rete stradale non serve più
per far muovere meglio gli eserciti, ma serve soprattutto a far
circolare più rapidamente uomini e cose. Giornali, radio e
televisioni continuano a essere oggetto di desiderio da parte
del potere, ma sempre più si sforzano di soddisfare le esigenze
di lettori e telespettatori. Con queste premesse è evidente che
una società può definirsi tanto più democratica e tanto più può
progredire quanto più i mezzi di comunicazione - tutti, dai
treni alle tv - svolgano un effettivo servizio. E qui vengono i
dolori. Dalle notizie di questi ultimi mesi, dalle inchieste -
come quelle che sta pubblicando la Gazzetta - emerge un'Italia
che in materia di comunicazione sembra compiere passi indietro.
E se si restringe l'obiettivo sulla sola Puglia la situazione si
fa allarmante, sia sotto il profilo politico che economico.
Lasciamo da parte il controverso conflitto d'interessi del
presidente del Consiglio, che pure risulta anomalo nel panorama
dei paesi democratici. Ma da qualche tempo assistiamo a un
peggioramento esponenziale di alcuni servizi come trasporti
ferroviari, poste e, in misura minore, strade e autostrade.
Troppo spesso si considerano questi strumenti solo per la
funzione economica - non a caso vengono classificati sotto la
voce «infrastrutture» - ma se ne sottovaluta la valenza sociale
e, in definitiva, politica. Allora mettiamola in termini un po'
rozzi ma certamente chiari: sui treni così come sugli autobus
viaggiano le persone più povere. Operai, impiegati, studenti,
pendolari, extracomunitari per viaggi brevi o lunghi che siano,
devono servirsi di questi mezzi. Se arrivano tardi, se sono
sporchi, se sono insufficienti non solo danneggiano
economicamente quegli utenti, ma tornano a riproporre la logica
sovrano-suddito. Perché la condizione sociale torna a
determinare le possibilità di affermazione delle persone. Negli
Stati Uniti esiste il diritto di ciascuno a ricercare la propria
felicità e, guarda caso, c'è anche il sistema di trasporti più
evoluto ed efficiente. Potremmo fare anche altri esempi, come le
poste. Sempre più si verifica l'assenza di postini per settimane
- soprattutto nei piccoli centri del Sud - con la corrispondenza
che giace nei cassetti. O con raccomandate che impiegano giorni
e giorni per percorrere pochi chilometri. Forse perché
raccogliere e consegnare lettere non dà molti profitti, forse
perché è meglio trasformarsi in banca, il servizio postale
peggiora di giorno in giorno. Eppure la libertà di comunicazione
interpersonale - quella attraverso le lettere - è uno dei tre
diritti inviolabili della persona, come ricorda l'art. 15 della
Costituzione. Ora, se parli al telefono sei intercettato, se
scrivi una lettera non arriva, al poverocristo che non abbia la
possibilità di ricorrere ad altri strumenti - e non ce l'ha per via della sua
condizione sociale - che cosa resta? Che cosa penserà dello Stato e in che modo
potrà evitare di considerarlo un tiranno buono a succhiargli, attraverso le
tasse, metà del suo reddito? Ecco, un treno pulito o una lettera che arrivi
puntuale è innanzitutto questione di democrazia.
È singolare come, in una
società che vive di comunicazione, per certe categorie sociali
sia sempre più difficile comunicare. E lo diciamo ricordando che
questa parola ha numerosi significati: da quelli più astratti a
quelli più concreti, addirittura fisici. C'è allora una
comunicazione che avviene attraverso giornali, radio,
televisione, internet, posta e c'è una comunicazione che avviene
attraverso strade, aeroporti e ferrovie. Storicamente la
comunicazione è sempre stata uno strumento di potere: chi
gestiva più notizie o aveva più mobilità riusciva a dominare gli
altri. La tanto celebrata lungimiranza di certi personaggi del
passato - da Cesare allo stesso Federico II - per quanto
lodevole, non è mai disgiunta dall'affermazione e dalla gestione
del potere. Le famose strade consolari romane sono state uno
strumento fondamentale per far funzionare l'impero. Così come le
aperture e gli scambi culturali del Grande Tedesco non sono
stati certo ininfluenti sulla tenuta del suo regno. È solo con
l'avanzata dei regimi democratici che i mezzi di comunicazione
perdono il vestito autoritario e assumono una dimensione di
servizio verso la società. Una buona rete stradale non serve più
per far muovere meglio gli eserciti, ma serve soprattutto a far
circolare più rapidamente uomini e cose. Giornali, radio e
televisioni continuano a essere oggetto di desiderio da parte
del potere, ma sempre più si sforzano di soddisfare le esigenze
di lettori e telespettatori. Con queste premesse è evidente che
una società può definirsi tanto più democratica e tanto più può
progredire quanto più i mezzi di comunicazione - tutti, dai
treni alle tv - svolgano un effettivo servizio. E qui vengono i
dolori. Dalle notizie di questi ultimi mesi, dalle inchieste -
come quelle che sta pubblicando la Gazzetta - emerge un'Italia
che in materia di comunicazione sembra compiere passi indietro.
E se si restringe l'obiettivo sulla sola Puglia la situazione si
fa allarmante, sia sotto il profilo politico che economico.
Lasciamo da parte il controverso conflitto d'interessi del
presidente del Consiglio, che pure risulta anomalo nel panorama
dei paesi democratici. Ma da qualche tempo assistiamo a un
peggioramento esponenziale di alcuni servizi come trasporti
ferroviari, poste e, in misura minore, strade e autostrade.
Troppo spesso si considerano questi strumenti solo per la
funzione economica - non a caso vengono classificati sotto la
voce «infrastrutture» - ma se ne sottovaluta la valenza sociale
e, in definitiva, politica. Allora mettiamola in termini un po'
rozzi ma certamente chiari: sui treni così come sugli autobus
viaggiano le persone più povere. Operai, impiegati, studenti,
pendolari, extracomunitari per viaggi brevi o lunghi che siano,
devono servirsi di questi mezzi. Se arrivano tardi, se sono
sporchi, se sono insufficienti non solo danneggiano
economicamente quegli utenti, ma tornano a riproporre la logica
sovrano-suddito. Perché la condizione sociale torna a
determinare le possibilità di affermazione delle persone. Negli
Stati Uniti esiste il diritto di ciascuno a ricercare la propria
felicità e, guarda caso, c'è anche il sistema di trasporti più
evoluto ed efficiente. Potremmo fare anche altri esempi, come le
poste. Sempre più si verifica l'assenza di postini per settimane
- soprattutto nei piccoli centri del Sud - con la corrispondenza
che giace nei cassetti. O con raccomandate che impiegano giorni
e giorni per percorrere pochi chilometri. Forse perché
raccogliere e consegnare lettere non dà molti profitti, forse
perché è meglio trasformarsi in banca, il servizio postale
peggiora di giorno in giorno. Eppure la libertà di comunicazione
interpersonale - quella attraverso le lettere - è uno dei tre
diritti inviolabili della persona, come ricorda l'art. 15 della
Costituzione. Ora, se parli al telefono sei intercettato, se
scrivi una lettera non arriva, al poverocristo che non abbia la
possibilità di ricorrere ad altri strumenti - e non ce l'ha per via della sua
condizione sociale - che cosa resta? Che cosa penserà dello Stato e in che modo
potrà evitare di considerarlo un tiranno buono a succhiargli, attraverso le
tasse, metà del suo reddito? Ecco, un treno pulito o una lettera che arrivi
puntuale è innanzitutto questione di democrazia.
La legalità e il lavoro
01/12/2005
La Gazzetta del Mezzogiorno
Vari anni fa colpì l'opinione pubblica l'immagine
di un gruppo di muratori siciliani che, durante la celebrazione del
primo maxiprocesso contro la mafia, erano stati fotografati nei
pressi dei cancelli del Tribunale di Palermo mentre, mostrando
cartelli su cui era scritto «W la mafia», inneggiavano a quella
organizzazione criminosa. La spiegazione di tale comportamento fu
che la mafia dava loro lavoro, mentre la guerra alla mafia,
chiudendo i cantieri edili gestiti da ditte collegate alla mafia, li
rendeva disoccupati. Questo ricordo è affiorato alla mia mente nei
giorni scorsi, quando ho notato che la manifestazione per il
centenario della CGIL, svoltasi a Foggia alcuni giorni fa, veniva
effettuata all'insegna dello slogan «la legalità è sviluppo». Mi
sono chiesto se è davvero sempre così oppure se non sia vero anche
il contrario, e cioè che è spesso la mancanza di sviluppo, come
avviene nel Meridione, e quindi la disoccupazione, a contribuire a
creare l'illegalità come ricerca della sopravvivenza. E la
complessità del problema, la difficoltà di separare nettamente
legalità e illegalità; di distinguere le vittime dagli sfruttatori,
trova tra i tanti un esempio significativo in quel che accade a
Bologna. E' stato merito indubbio del sindaco di Bologna, Cofferati,
quello di far esplodere in tutta la sua drammaticità il problema
della legalità. Al contrario di quanto spesso si pensa, Cofferati
non dice affatto che non si deve distinguere tra illegalità lieve e
grave; non pratica la tolleranza zero, ma dice altro. Dice infatti
di aver cominciato dai lavavetri l'operazione per il rispetto della
legalità perché essi sono l'anello debole - ma sempre un anello -
della catena del racket degli sfruttatori. E ciò vuol dire che essi
concorrono in realtà a perpetuare l'illegalità più grave, ne sono
tacitamente complici. Egli poi aggiunge: «Se un lavoratore in nero
viene da me, mi dice come si chiama e chi è il caporale che lo
sfrutta, lo porto dal questore e dal prefetto e lo aiuto. Se non lo
farà, verrà allontanato». Ma questo discorso non è condivisibile per
varie ragioni: 1) perché dà per scontato che un racket vi sia
sempre, mentre la legge esige che sia accertato caso per caso non
solo che vi siano situazioni di violenza o di grave sfruttamento, ma
anche che emergano concreti pericoli per l'incolumità
dell'immigrato; 2) perché esige dall'immigrato l'eroismo, la
capacità (molto coraggiosa) di ribellarsi ai suoi aguzzini anche a
costo di correre gravi rischi, quando quell'eroismo non viene
richiesto a quella vasta parte della popolazione italiana che
subisce in silenzio omertoso i taglieggiamenti ed il pizzo ed i
morti causati dalla mafie. 3) Perché trasforma l'immigrato-vittima
del racket in un correo del medesimo. L'inevitabile, ma
inaccettabile conclusione è che non distinguere tra vittima e
sfruttatore significa rifiutare la cultura del «cattolicesimo
compassionevole», (quello che spingeva don Tonino Bello ad aprire
agli immigrati le porte del vescovado di Molfetta), che ci ha sempre
contraddistinto e che coniuga legalità con solidarietà, in funzione
della costante tutela della dignità umana, come dice don Luigi
Ciotti.
L'inquietudine
della terza età
di DAVID BIDUSSA
da La gazzetta del
Mezzogiorno del 1-12-2005
Nelle settimane scorse
il conflitto giovani-anziani ha fatto di nuovo capolino sulle pagine dei
giornali. Non ultimo è anche uno dei fattori determinanti della rivolta
delle banlieue. La rivolta della terza generazione non dice solo che non si
è inclusi nella società, dice che dopo due generazioni di ascesa o di
promozione il trend si è arrestato e le attese di successo sono divenute
impossibilità di avanzamento. Dunque abbiamo un'emergenza giovanile. Ma
questo aspetto non è un dato eccezionale. Almeno a partire dalla crisi della
bottega artigianale fondata sul modello gerarchico capomastro-apprendista
(appunto vecchio-giovane) fino a tutte le forme di rivolta del Novecento la
sociologia della ribellione ha sempre posto al centro l'inquietudine
giovanile. Questo è stato vero in particolare nel Novecento e lo è stato
trasversalmente sull'asse destra-sinistra. Il primo fascismo urbano dei
reduci dalle trincee non era antropologicamente diverso dallo spirito
dissacratore che presenteranno i loro pronipoti nelle piazze e nelle strade
italiane nella primavera-estate del 1977 ai tempi dell'«autoironia» degli
«indiani metropolitani». Eppure nel tempo si è improvvisamente imposto un
altro tema nei confronti del quale dovremmo imparare ad attrezzarci, cioè la
persistenza degli anziani e il problema della vecchiaia come problema
culturale, alla pari della questione giovanile, anzi, forse, più dirompente
di quella. Dopo una cultura giovanile, dobbiamo attrezzarci, in tempi brevi,
per una «cultura senile». Ovvero costruire un'idea dell'utilità o della
funzionalità sociale degli anziani. Anche senza considerare la dimensione
del vecchio nelle società tradizionali come sinonimo di sapienza, autorità,
venerazione, non è senza significato che nel giro di due generazioni noi
siamo passati da una dimensione dei vecchi come «padri dispotici», a una in
cui il vecchio appare come figura debole, vittima indifesa e, soprattutto,
inutile - in gergo economico annoverabile solo nel capitolo delle «uscite» e
non in quello delle «entrate». Una condizione ulteriormente accelerata da
una certezza. Ovvero il fatto che «nella civiltà a base Google - come scrive
Régis Debray (Fare a meno dei vecchi. Una proposta indecente, Marsilio) -
con la console, la tastiera e il mouse, non c'è più niente di appetibile
sulla tavola del nonno. Siamo la prima civiltà in cui la competenza
acquisita è di ostacolo alle competenze da acquisire; la prima civiltà in
cui il giovane se la cava meglio del vecchio; il cui il piccolo è più dotto
e più esperto del grande, che sbircia alle spalle del bambino per sapere
come funzioni l'ultimo software». Ma questa convinzione se non inaugura una
politica sociale non consente di intravedere una risposta ad ampio raggio.
La seconda metà del Novecento con le politiche su tutela della salute,
qualità dell'alimentazione, organizzazione del welfare, avanzamento della
ricerca scientifica e medica in particolare, ci ha consegnato società in cui
gli anziani costituiscono una porzione rilevante e nelle quali, in
prospettiva, il loro numero crescerà. Quella degli anziani non è più solo
una questione di assistenza, né la costruzione di un «beota consumatore
felice» (sessualmente soddisfatto dalla distribuzione gratuita di viagra).
E' una questione che riguarda come si organizzano la vita quotidiana, le
strutture delle città, i tempi dell'intrattenimento, il ventaglio delle
offerte sul tempo libero. Come per la questione giovanile, anche per gli
anziani non si tratta di inventare politiche di assistenza, o di delegare
alle famiglie una loro salvaguardia. E' un intero assetto culturale delle
politiche sociali che va pensato e costruito. Quella degli anziani, a meno
di non pensare a un accorciamento delle aspettative di vita, è una questione
che riguarda - al pari dell'ambiente - le nostre società locali e nazionali,
su cui non solo costruire iniziative specifiche all'interno di assessorati o
dicasteri dedicati alle emergenze sociali o alla salute, ma inventarsi un
intero assetto di intervento e di programmazione autonoma e specifica a
partire già dalle prossime scadenze elettorali, anche perché gli anziani
votano. * David Bidussa è storico. Si occupa di storia sociale delle idee.
01/12/2005
La sinistra malata di programmismo
Dario Di Vico
Un nuovo fantasma si
aggira per l'Italia: il programmismo. A Roma come a Bologna
si susseguono incontri e seminari per i menu elettorali di Ds,
Margherita e Ulivo. I dirigenti ascoltano e riempiono quaderni di
appunti. Ma come stanno davvero le cose? Gli esperti più attenti —
che corrono trafelati di fondazione in fondazione per partecipare a
queste audizioni — raccontano gli anni della gelata. Anni in cui
molte aziende sono finite fuori mercato ma altrettante hanno
sviluppato un'insospettata capacità di reazione.
Nel Nord-Est si narra di
imprese dei distretti friulani che hanno imparato a
fabbricare non solo coltelli e mobili ma prodotti a maggiore valore
aggiunto, componenti per turbine o interni per navi da crociera. I
dati lo confermano: negli ultimi dieci anni i volumi delle
esportazioni sono calati dal 5,3 al 3,1% ma il valore delle merci
vendute è rimasto pressoché lo stesso. Esportiamomeno coltelli ma
più tecnologia e organizzazione. Protagonista di queste performance
è stata la media impresa ma anche tra le grandi non mancano esempi
virtuosi. Il gruppo siderurgico di Emilio Riva nel 2002 perdeva 180
milioni di euro e in due anni è arrivato a guadagnarne 1.040,
insediandosi così al quarto posto per redditività subito dopo il
trio Eni, Enel e Telecom. La Fiat, a cui lucide menti del merchant
banking avevano pronosticato l'approdo nella Cassa Depositi e
Prestiti o nella Finpinerolo, si è tirata su con le sue forze.
L'industria dunque ha reagito, non si è rassegnata nonostante
l'assenza di una politica per la competitività. Il vero ministro
dell’Industria di questi anni è stato Charles Darwin e non certo
Antonio Marzano.
Oggi l'Economist renderà
nota, alla presenza di Mario Monti, Enrico Salza e Marco
Tronchetti Provera, la sua inchiesta sull'Italia e i giudizi sul
governo in carica si annunciano severi. Nella crisi di Bruxelles il
settimanale londinese è diventato il nostro nuovo vincolo esterno.
Ma dopo aver brandito per cinque anni quel giornale come una spada
contro l'unfit Silvio Berlusconi, la novità è che stavolta
l'opposizione troverà valutazioni critiche nei suoi confronti.
Rischia di esaurirsi la più ricca delle rendite politiche: avere
dalla propria parte la voce dei mercati finanziari.
Siamo al più classico
degli hic Rhodus, hic salta. Il centrosinistra continua a
trastullarsi con l'idea di cancellare tutte le leggi del recente
passato. Nei convegni si ascoltano ricette contraddittorie: chi
invoca le liberalizzazioni e chi un nuovo Iri, chi critica il
socialismo municipale e chi ammicca al dirigismo francese. Quando si
passa a scrivere, le due tesi finiscono per sommarsi dimenticando
che a salvarsi è stata l'industria «liberale », non quella
assistita. Si ricade così nel programmismo. Un film già visto:
quante volte il centrosinistra ha affidato ai suoi intellettuali più
prestigiosi, agli Amato e ai Salvati, l'onere di comporre le
divergenze e scrivere il Programma? E quante volte quei preziosi
incunaboli sono finiti dimenticati negli scaffali dei centri studi?
Tutto si può dire del centrodestra ma occorre riconoscerne l'abilità
nell'indicare priorità che sono rimaste nella memoria. E allora
viene spontaneo chiedere al centrosinistra, ma anche alla vasta area
di intellettuali che in quel campo si riconosce, di provare a fare
altrettanto. Indicare tre-quattro provvedimenti che si impegna ad
approvare nella primissima fase di governo. Cento righe, non di più,
per spiegare agli italiani dove li si intende portare. Non ci
sarebbe niente di più fit.
24 novembre 2005 Corriere della Sera
Modello De Gasperi tra
Stato e Chiesa
da La Gazzetta del Mezzogiorno del 21-11-2005
di
CARLO GALLI
Scomparsa la Dc, che costituì un freno moderatore per le richieste della Chiesa
cattolica, e seppe quasi sempre ricondurle nell'alveo di una statualità
equilibrata, e morto Giovanni Paolo II, la Chiesa percepisce ora la forza della
crisi che investe la religione in Occidente. Le gerarchie sanno bene che la
pratica religiosa non cresce, che l'accesso ai sacramenti (si pensi al
matrimonio) è in decremento; che il cattolicesimo è minoritario nella società
italiana. Per non parlare dell'Europa o del resto del mondo. E' una Chiesa che
teme di veder sfuggire la propria presa sulla società quella che perentoriamente
suggerisce ai politici come legiferare sui Pacs e su ogni altra questione etica
e bioetica; è cioè non soltanto una Chiesa priva di vie di intermediazione con
la politica, ma anche una Chiesa scavalcata dai tempi. Comunque, la Chiesa «alza
la voce» non solo per ammonire i propri fedeli, ma anche per proporre le proprie
vedute a tutta la società e per salvarla dalla disgregazione. Ma il punto è che
gran parte delle richieste della gerarchia, nelle forme e nei modi, appaiono
problematiche alla luce del Concordato che, in cambio di importanti privilegi
concessi alla Chiesa cattolica, richiede alla parte ecclesiastica lealtà verso
lo Stato, cioè un sostanziale rispetto non solo della sua autonomia ma anche
della sua laicità. E questa significa che il potere pubblico si impegna a
consentire a ciascuno di vivere secondo i propri valori, ma anche a impedirgli
di obbligare il prossimo a uniformarvisi. Che cioè lo Stato è il garante del
pluralismo. Questa laicità vale anche se lo Stato ha riconosciuto con lo
strumento concordatario la peculiare rilevanza storica di una confessione
religiosa: il Concordato non fa dello Stato italiano uno Stato confessionale. La
Chiesa deve quindi riconoscere apertamente la laicità dello Stato - non la
laicità «bene intesa», ma la laicità come principio generale -, oppure
rinunciare ai propri privilegi e rassegnarsi a essere una lobby, in libera
concorrenza con le altre nell'arena politica e sociale. Perché ciò avvenga,
tuttavia, è necessario un radicale rafforzamento della politica (delle
istituzioni e degli uomini), e soprattutto della consapevolezza che essa deve
avere della propria intrinseca dignità e dei propri doveri davanti a tutti i
cittadini, del fatto cioè che è essa la prima portatrice di un legittimo
interesse universale, quello appunto della libertà di tutti. Il che dovrebbe
portarla a operare perché il cattolicesimo, pur nella piena libertà di cui deve
godere, non divida la società italiana, della cui libertà complessiva - cioè
valida per tutti - lo Stato deve essere il garante. Mentre, in realtà, si
assiste ora alla rincorsa alla benevolenza della Chiesa (la questione dell'Ici
sui beni ecclesiastici ne è solo un aspetto) di cui si approvano o disapprovano
le posizioni secondo il tornaconto degli schieramenti. Sabato Berlusconi è
tornato dalla sua visita privata in Vaticano sbandierando un pieno accordo col
pontefice sulle questioni internazionali (è dunque superato il No di Giovanni
Paolo II alla guerra in Iraq?) e su quelle interne «nello spirito del
Concordato» (qualunque cosa voglia dire); ma ha dovuto incassare (non si sa
quanto a malincuore) un No dei vescovi alla devolution. E Fassino, da parte sua,
ha improvvidamente consentito alle critiche ecclesiastiche alla riforma della
costituzione, quando, qualche ora dopo, Ruini ha proposto di mandare volontari
cattolici nei consultori (il che darebbe una patina confessionale a una funzione
pubblica). Per porre rimedio a tale stato di cose, in realtà, non occorrono né
nuovi conflitti di religione, né politici sul modello di Robespierre o di Lenin.
Tutto quello di cui c'è bisogno sarebbero figure come quella di De Gasperi, un
vero credente e un vero statista, che fu capace di opporsi, in materia politica,
a un «papa-re» come
Pio XII.
Purtroppo, è molto difficile che qualche politico di oggi sia capace di essere
«laico» come quel grande democristiano.
Senise, la crisi ha messo
radici
Da
Il
Sole 24 ore del 16-11-2005
di Massimo Brancati
C’è
un Sud nel Sud, un’emergenza nell’emergenza. Si chiama
Senisese: è la zona della Basilicata dove allo storico degrado socio-economico,
dovuto soprattutto a carenze di natura infrastrutturale, si aggiungono gli effetti di una crisi
generale che qui amplifica la sua onda d’urto, traducendosi, in particolare, in
un tasso di disoccupazione che oggi è del 23,12 per cento (in Basilicata è del
12,1), cresciuto di 10 punti dal 2000 al 2005. I dodici paesi del comprensorio,
a cominciare da Senise, appartengono a quella che l’Istat
definisce «fascia dell’impoverimento», caratterizzata da indici di alta criticità rispetto alla produzione, all’assistenza,
al commercio, al turismo, al reddito. Nei centri dell’area il pil pro-capite è simile a quelli registrati in Paesi
dell’Europa dell’est: il più basso è a Calvera (5.628 euro), seguono Cersosimo (5.897 euro), Paterno
(6.211 euro) fino ad arrivare a Senise che con 8.200 euro è la realtà locale
più ricca (si fa per dire). Dati che risaltano di più se confrontati con il pil di altri centri lucani, la cui
entità è influenzata da fattori produttivi ancorati al territorio: Melfi, che
ospita lo stabilimento Fiat, è a quota 43.330 euro. L’effetto-petrolio, invece,
si fa sentire soprattutto a Grumento Nova (31.511
euro) e Viggiano (26.225 euro).
Potenza e Matera, i due capoluoghi di provincia, si attestano rispettivamente a
26.276 e 22.677 euro.Fiat e «oro nero», dunque,
incidono in maniera determinante sul prodotto interno
lordo. Così come i salotti del Materano e le aziende situate
nelle otto aree industriali lucane. Direttrici di sviluppo che non
toccano il Senisese, una zona, dunque, emarginata dai principali segmenti
produttivi e con l'agricoltura che non riesce a decollare: i peperoni di Senise
e i fagioli di Sarconi solo da un paio d'anni
cominciano ad affacciarsi oltre i confini regionali. Tutto ciò determina una
tendenza migratoria elevatissima ed un graduale processo di decadimento socio-economico che, inevitabilmente, si accompagna al
degrado fisico del territorio. I problemi che affligono
il comprensorio riguardano l’istruzione (diminuzione del numero degli studenti
ampiamente superata dal numero di scuole chiuse); l’assistenza sociale (scarsi
operatori, riduzione servizi); la superficie agricola (in calo del 60%
nell’ultimo decennio, con crescita della superficie improduttiva); il commercio
(in un solo anno le licenze per imprese di commercio al dettaglio sono
diminuite del 33%); la dinamica turistica (presenze
turistiche inconsistenti). Di fronte a questo puzzle di problematiche, interi
paesi si stanno letteralmente svuotando. L’emigrazione è tornata ai livelli
degli anni ’60-’70, vanificando il boom demografico degli anni ’80-’90. Paesi
come Carbone (il cui tasso migratorio è del 22,8 per cento
secondo quanto riportato dall’Istat), San
Martino d’Agri (19) e Senise (11,6) sono alle prese con un processo di
spopolamento di notevole portata (il tasso medio regionale è del 9,10 per
cento).«Le risorse naturali ambientali della zona - spiega l’economista Nino D’Agostino - sono scarse. I tentativi di avviare
processi di industrializzazione sono stati vanificati
da una rete viaria a dir poco approssimativa, con collegamenti che rendono
difficili gli interscambi. Anche per questo - aggiunge - il Senisese è stato
escluso dalle direttrici produttive che reggono le sorti economiche della
regione, dal petrolio alla Fiat e ai salotti. L’area,
insomma, è marginale e ha scarse risorse endogene: accoppiata devastante. E i risultati sono evidenti».Schegge di una
industrializzazione che ha soltanto sfiorato il Senisese. Schegge che si stanno dissolvendo sotto i colpi della crisi
economica: dal 2001 ad oggi hanno chiuso i battenti sei aziende, con
un’emorragia di posti di lavoro e di speranze. Hanno cessato l’attività
- per ragioni che vanno dalla mancanza di commesse alla crisi dei mercati - la Lucana calzature di Maratea,
l’Iris Biomedica e la Ovisud
di Senise, la T & A Itv di Trecchina, la Cia e Siderlame di Viggianello. Complessivamente i posti di lavoro garantiti
da queste aziende erano circa 400, per l’esattezza 273 Lucana calzature, 21
Iris biomedica, 14 Ovisud,
42 T & A, 20 Cia, 15 Siderlame.
Ci sono anche altre realtà produttive in sofferenza, tra le quali la Flomar di Maratea, che occupa una
quarantina di lavoratori.Accanto alla crisi delle
aziende spaventa il rischio di un mancato ammodernamento del tratto lucano
dell’A3 Salerno - Reggio Calabria con tutto quanto ne può derivare in termini
di collegamenti e di occupazione (i sindacati di
categoria quantificano in 2.000 unità i lavoratori che potrebbero essere
impegnati se i cantieri fossero aperti). I segnali che giungono dal Governo
centrale non sono incoraggianti: nella Finanziaria non
ci sarebbe traccia del finanziamento destinato all’opera. Ipotesi che ha
seminato il panico tra i sindaci dell’area: «Siamo pronti - dicono - anche ad
azioni clamorose per farci sentire dalla Regione e dal Governo nazionale». E intanto gli stessi primi cittadini propongono un consorzio
pubblico - privato per rilanciare lo sviluppo e l’occupazione del comprensorio.
Proposta che trova sulla stessa lunghezza d’onda anche la Comunità montana,
consiglieri regionali e provinciali dell’area, sindacati, Api (Associazione
piccoli imprenditori). Il consorzio dovrebbe servire, in particolare, a
rilanciare il settore turistico con il coinvolgimento di tutte le potenzialità
offerte dal territorio, a partire dall'area che
gravita attorno all'orbita del Pollino. A questo, è stato detto, bisognerebbe
abbinare anche misure di sostegno alle piccole imprese. «Abbiamo - dice il
presidente della Comunità montana del Lagonegrese,
Domenico Carlomagno - tante piccole aziende che vanno
aiutate ad ampliare la loro attività per incrementare l’occupazione e resistere
ai venti di crisi».
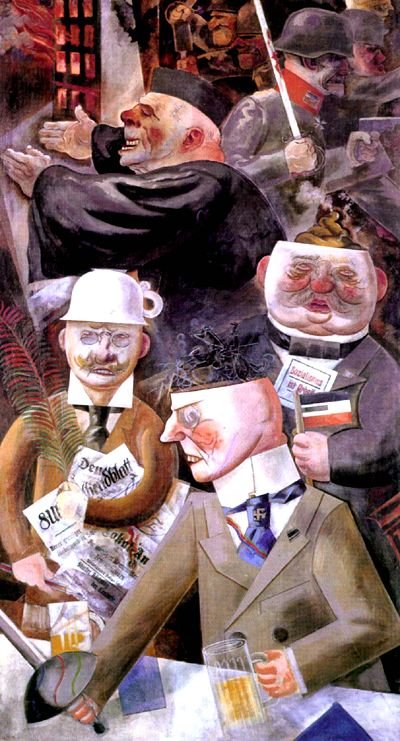 Più
di 100 giornali o periodici cattolici sono finanziati dallo
Stato. Ma non erano sufficienti l'otto per mille e l'esenzione degli immobili
religiosi dall'ICI? Le nostre tasse contribuiscono a "La Voce dei Berici
della Diocesi di Vicenza" e a "La Valsusa della Stampa Diocesana
Segusina".
Più
di 100 giornali o periodici cattolici sono finanziati dallo
Stato. Ma non erano sufficienti l'otto per mille e l'esenzione degli immobili
religiosi dall'ICI? Le nostre tasse contribuiscono a "La Voce dei Berici
della Diocesi di Vicenza" e a "La Valsusa della Stampa Diocesana
Segusina". Di
fronte al numero sterminato di giornali assistiti la prima
reazione è di farne subito uno per prendere finalmente uno stipendio. Se
Fare Vela e Sportsman -Cavalli e Corse hanno ricevuto un
finanziamento lo possono pretendere tutti, dai blog ai giornali di quartiere
Di
fronte al numero sterminato di giornali assistiti la prima
reazione è di farne subito uno per prendere finalmente uno stipendio. Se
Fare Vela e Sportsman -Cavalli e Corse hanno ricevuto un
finanziamento lo possono pretendere tutti, dai blog ai giornali di quartiere Quotidiano, «primo quotidiano di Benevento» e Rinascita). A
seguire il milione e 601 mila euro della Dolomiten di
Bolzano, il milione e 586 mila di Scuola Snals, il
milione e 406 mila di Nuovo Corriere Bari Sera, il
milione e 313 mila di Provincia Quotidiano di Frosinone,
il milione e 224 mila del Cittadino Oggi di Siena, il
milione e 185 mila della Verità, il milione e
272 mila della Voce di Mantova; i buoni piazzamenti,
sul milione di euro, dell’agenzia Area (storicamente legata
all’area ex PCI e fornitrice di decine di emittenti locali) e di Ottopagine
(«quotidiano dell’Irpinia a diffusione regionale» in vendita a 50 centesimi); i
916 mila euro di Dossier News di Caserta - Il
Giornale, gli 891 mila di Cronache del Mezzogiorno, i
753 mila dell’agenzia Dire.
Quotidiano, «primo quotidiano di Benevento» e Rinascita). A
seguire il milione e 601 mila euro della Dolomiten di
Bolzano, il milione e 586 mila di Scuola Snals, il
milione e 406 mila di Nuovo Corriere Bari Sera, il
milione e 313 mila di Provincia Quotidiano di Frosinone,
il milione e 224 mila del Cittadino Oggi di Siena, il
milione e 185 mila della Verità, il milione e
272 mila della Voce di Mantova; i buoni piazzamenti,
sul milione di euro, dell’agenzia Area (storicamente legata
all’area ex PCI e fornitrice di decine di emittenti locali) e di Ottopagine
(«quotidiano dell’Irpinia a diffusione regionale» in vendita a 50 centesimi); i
916 mila euro di Dossier News di Caserta - Il
Giornale, gli 891 mila di Cronache del Mezzogiorno, i
753 mila dell’agenzia Dire.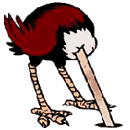 90
nell’area stabiese-sorrentina, tornese vesuviana, agro-nocerino-sarnese,
salernitano, avellinese»), il settimanale in sloveno Novi Matajur, il
«mensile di Agricoltura Alimentazione e Ambiente» Oep-Notiziario Agricolo
Spazio Rurale, Ore 12, Qui («settimanale di informazione
della Provincia di Ravenna»), il «settimanale di Imola» Sabato Sera, il
settimanale Sole delle Alpi che si propone di «far riscoprire le
culture locali, oramai vittime della globalizzazione culturale ed ideologica»,
il mensile Rivista Italiana Difesa «pubblicazione leader del settore in
Italia fin dal primo numero»...
90
nell’area stabiese-sorrentina, tornese vesuviana, agro-nocerino-sarnese,
salernitano, avellinese»), il settimanale in sloveno Novi Matajur, il
«mensile di Agricoltura Alimentazione e Ambiente» Oep-Notiziario Agricolo
Spazio Rurale, Ore 12, Qui («settimanale di informazione
della Provincia di Ravenna»), il «settimanale di Imola» Sabato Sera, il
settimanale Sole delle Alpi che si propone di «far riscoprire le
culture locali, oramai vittime della globalizzazione culturale ed ideologica»,
il mensile Rivista Italiana Difesa «pubblicazione leader del settore in
Italia fin dal primo numero»...
 Che
fine hanno fatto quei 23 fusti di «rifiuti radiottivi» risultati mancanti all’Itrec
di Rotondella secondo quanto emerso in un’ispezione del 1982 finita in un’i n ch
i e s t a della Procura di Matera? Da dove sono partiti, e per decisione di chi,
le forniture di uranio di cui si parla in un documento della Cia di recente
descretato dalla Casa Bianca e nel quale si descrive come nel '79 e nel '82 «la
Snia-Techint, attraverso il Cnen» effettuò tre vendite al regime di Saddam
Hussein, che intendeva dotarsi di armamenti atomici?
Che
fine hanno fatto quei 23 fusti di «rifiuti radiottivi» risultati mancanti all’Itrec
di Rotondella secondo quanto emerso in un’ispezione del 1982 finita in un’i n ch
i e s t a della Procura di Matera? Da dove sono partiti, e per decisione di chi,
le forniture di uranio di cui si parla in un documento della Cia di recente
descretato dalla Casa Bianca e nel quale si descrive come nel '79 e nel '82 «la
Snia-Techint, attraverso il Cnen» effettuò tre vendite al regime di Saddam
Hussein, che intendeva dotarsi di armamenti atomici?  cittadino americano dell'Ontario che lavorava per il supercannone di Saddam
Hussein. Venne ritrovato morto in Belgio nel marzo 1990. L'assassinio non è
ancora risolto ma funzionari della Cia affermano che con molta probabilità il
Mossad, il potente servizio segreto israeliano, ne era coinvolto nell’ambito
delle sua nuova strategia di colpire quanti collaboravano con chi minacciava la
sicurezza dello Stato di David anche oltre i propri confini. E siamo ad un nuovo
punto cruciale. Perchè se è certo che a Rotondella arrivarono tecnici sia
pakistani (Paese che ha completato da un decennio il suo processo per giungere
all’ato - mica) che iracheni, secondo la Cia, il 12 dicembre del 1979,
dall’Italia sono partiti tre carichi: uno di diossido d’uranio depleto (6.005
kg), e due di diossido d’uranio naturale, per complessivi 4.506 chili. Poi, il
18 maggio del 1982, sono stati inviati «1.767 kg di diossido d’uranio a basso
livello d’arricchimento». Ma non una parola su come questi materiali siano stati
inviati, anche se certamente non c’è da attendersi che siano stati soggetti a
regolare movimentazione.
cittadino americano dell'Ontario che lavorava per il supercannone di Saddam
Hussein. Venne ritrovato morto in Belgio nel marzo 1990. L'assassinio non è
ancora risolto ma funzionari della Cia affermano che con molta probabilità il
Mossad, il potente servizio segreto israeliano, ne era coinvolto nell’ambito
delle sua nuova strategia di colpire quanti collaboravano con chi minacciava la
sicurezza dello Stato di David anche oltre i propri confini. E siamo ad un nuovo
punto cruciale. Perchè se è certo che a Rotondella arrivarono tecnici sia
pakistani (Paese che ha completato da un decennio il suo processo per giungere
all’ato - mica) che iracheni, secondo la Cia, il 12 dicembre del 1979,
dall’Italia sono partiti tre carichi: uno di diossido d’uranio depleto (6.005
kg), e due di diossido d’uranio naturale, per complessivi 4.506 chili. Poi, il
18 maggio del 1982, sono stati inviati «1.767 kg di diossido d’uranio a basso
livello d’arricchimento». Ma non una parola su come questi materiali siano stati
inviati, anche se certamente non c’è da attendersi che siano stati soggetti a
regolare movimentazione.  Inchiesta
sui dati del programma operativo Val D'Agri attuato con i fondi del petrolio
Inchiesta
sui dati del programma operativo Val D'Agri attuato con i fondi del petrolio